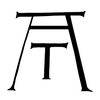di Daniela Rossella
(Università degli Studi di Potenza)
per la serie di interventi “Miti che odiano le donne“
Si può abrogare un mito, chiuderlo in un cassetto e addio per sempre? Certamente no, e il fuoco che brucia a morte, ignominiosamente, spesso con il silenzio-assenso dei congiunti e delle autorità, tante neo spose hindū colpevoli di non aver fornito una dote sufficiente – o di non averne fornita d’ulteriore – dopo che le loro famiglie si sono, di frequente, indebitate per raggranellarne una, dimostra che le fiamme che ardono le donne ancora oggi non si sono spente. L’atroce fenomeno del bride burning è fra i più tristemente noti dell’India contemporanea. [1]
All’origine di tutti i roghi c’è il mito di Satī, moglie del dio Śiva. L’“antica storia” (purāṇa), [2] che in definitiva dà lo spunto a tutti gli women’s burnings, è ben nota: la “Virtuosa”, la “Perfetta”, si sarebbe arsa per vendicare un’ingiuria inflitta dal proprio padre, Dakṣa, al marito, fornendo così il prototipo indecente e crudele della moglie integerrima che è disposta a morire, ossia alla suprema espiazione, per salvaguardare l’onore della famiglia e santificare l’obbedienza allo sposo e la sua indiscutibile superiorità.
Se è vero, come vero è, che si chiamano satī le vedove che s’immola(va)no sulla pira funeraria del marito defunto, il mito-archetipo di Satī, a logica, non regge: Śiva è vivo e vegeto e manca dunque il requisito essenziale dell’anumaraṇa (“il morire dopo”), ossia appunto la vedovanza. Quel che non manca, invece, è il portato di fondo: una moglie può, anzi deve, sacrificare la propria vita in nome di un patto di sudditanza stipulato al momento del matrimonio, vincolo per lei necessario e ineludibile, e per lei sola inscindibile, al fine di acquisire l’unico e agognato status anche religiosamente qualificante, quello di moglie. Non diffuso nell’antichità più remota, e certo mai fenomeno di massa, l’abbruciamento della vedova sulla pira funeraria del marito (abolito per legge, ma non di fatto, già dagli inglesi nel 1829 e ancor oggi, sia pure saltuariamente, [3] praticato) sta appunto a significare che, senza il partner, la moglie non vale nulla: per essere più precisi, la femmina, in quanto tale, deve pubblicamente e ritualmente attestare che la vita senza il marito (nei tempi antichi come ancor oggi di frequente scelto dalla famiglia tramite matrimonio combinato o semi-arranged) è inaccettabile, o meglio: indecorosa. La satī non è una suicida: psicologicamente programmata a “andare insieme [con il marito]” (sahagamana) in quanto – assurdamente – ritenuta in qualche modo colpevole della morte del partner (a causa del proprio karman negativo o di presunte inadempienze compiute nella vita coniugale), forzata al gesto dalle incredibili pressioni della famiglia, della società e dei detentori del potere religioso, mai, in nessun caso, una donna si buttò tra le fiamme, viva, per amore. Chi lo volle credere (molti viaggiatori occidentali dal medioevo agli albori dell’età moderna, che sottolinearono l’aspetto eroico del gesto, e qualche benpensante hindū in buona fede) è, nel migliore dei casi, vittima a sua volta di un mito: che l’amore, per essere vero ed eterno, pretenda il cadavere di chi ha amato, ma guarda caso nel contesto in questione non ci sono Romei, ma solo Giuliette. [4]

Del resto, percosse, intimidazioni e violenze per le riluttanti – abbondantemente testimoniate –, anche da parte dei membri delle loro stesse famiglie, spazzano via ogni barlume di romanticismo eventualmente intessuto intorno alla ributtante usanza. Non possiamo viceversa escludere che, a volte, forse, la donna s’immolasse terrorizzata al pensiero di trascorrere una non-vita da vedova: ossia, priva ormai del “necessario” marito, disprezzata, deprivata d’ogni segno di femminilità – si pensi alla rasatura dei capelli, alla spoliazione dai gioielli, all’obbligo d’indossare misere vesti bianche, il colore del lutto –, considerata di malaugurio, scacciata di casa, costretta a prostituirsi o a sostentarsi di elemosine e, naturalmente, impossibilitata a risposarsi. Tipico e tragico è il caso delle vedove di Vṛndavan.
Non sapremo mai, dunque, quante furono le vedove-vittime consenzienti (o quasi) di questo rituale solenne, peraltro grottescamente simile, nella prassi, alla cerimonia nuziale, creato a bella posta dalla classe sacerdotale (probabilmente anche tramite programmatica manomissione di un celebre inno dei sacri Veda) [5] per sancire di fatto quello che la tradizione, senza mai essere esplicita e univoca, nei secoli volle affermare: non è dato a una sposa sopravvivere al suo “signore”, dando corpo non già al binomio amore-morte, bensì a quello sudditanza femminile-eliminazione della donna.
Un fatto è dunque sicuro: tramite questo gesto espiatorio, ritualizzato, pubblico e feroce la cultura hindū, o almeno parte di essa, escogitò il modo di liberarsi di un soggetto sociale ritenuto non più vantaggioso, da vivo, ma largamente utile da morto, poiché la satī reca (come il suo stesso epiteto comporta) “santità”, ossia surplus etico-religioso, alla famiglia propria e a quella acquisita e al gruppo sociale – nonché, per lei stessa, quale premio di consolazione, un soggiorno celeste o una rinascita migliore. Possibilmente, in quest’ultimo caso, in un corpo maschile e di casta alta: in un “abilitato”, cioè, a dar seguito alla classe d’appartenenza e alla famiglia, a eseguire i rituali, a perseguire infine – se lo desidera – quel legittimo e lodevole fuoco (tapas) che è l’ascesi. Un fuoco, quest’ultimo, precluso s’intende alle donne, ritenute per tradizione indegne o incapaci di profondità spirituali e di aggiogamento dei sensi, “patrimonio” dei soli maschi: solo da pochi decenni, infatti, si assiste al fenomeno, peraltro controverso e discusso dall’ortodossia, delle donne-ascete, alcune delle quali sembrano peraltro aver scelto questo stile di vita perché rigettate dalla società in quanto vedove, abbandonate dal marito o zitelle.
Quanto, ancora, a “colei che segue il marito”, non vanno sottaciuti anche i vantaggi economici: eredità non più da spartire, per esempio, una bocca in meno da sfamare, costosi souvenir (“santini” veri e propri) da smerciare sul luogo dell’abbruciamento e, non da ultimo, doti da intascare. E le moderne satī sono appunto le spose che periscono a causa delle dowry deaths secondo l’uso, come ovvio illegale e perseguito per legge, del bride burning: troppe femmine, malamente accolte (di frequente oggi ancora) alla nascita (sempreché non abortite prima di vedere la luce grazie a una provvidenziale amniocentesi), assillate dalla necessità di maritarsi il prima possibile e smerciate rapidamente al migliore acquirente soltanto dietro pagamento di una dote cospicua, e infine divenute in fretta e furia giovanissime spose, prendono fuoco per un “incidente” (una stufa o una cucina che scoppiano), complici non di rado esattamente coloro dalle quali ci si aspetterebbe comprensione e complicità: la suocera e le cognate. Non c’è scusa o perdono per queste assassine (che peraltro nella gran parte dei casi, statistiche alla mano, la passano liscia), [6] ma va detto che, a modo loro, sono esse stesse vittime di quel masochistico mito secondo il quale, per l’appunto, la vita di una donna vale un pugno di rupie (o di euro). Inutile dire che il vedovo, liberatosi della moglie “inadempiente”, si reimmette prontamente nel mercato nuziale: qualcuno, di certo, starà già preparando una dote, e una sposina, nuove di zecca.
C’è chi poi, nel mito, nel fuoco passa attraverso indenne, ma senza un happy end vero e proprio: ed eccoci a Sītā, protagonista, col sovrano-dio suo sposo, Rāma, dell’inossidabile Rāmāyaṇa. Letta, recitata, inscenata, tramutata in serial televisivi, [7] in fumetti o in cartoni animati, [8] l’epica non perde di smalto: e ogni giorno ancora, nell’immaginario collettivo, Sītā segue il marito nell’ingiusto esilio (causato, peraltro, dall’immancabile matrigna intrigante e funesta), viene rapita dal demone Rāvaṇa (su istigazione d’un’altra femmina maligna, la di lui sorella Śūrpaṇakā, alla quale non era riuscito di sedurre Rāma) e infine è ritrovata e riscattata. Ma non redenta: benché di notoria esemplare lealtà, le tocca un’ordalia per dimostrare d’esser stata casta (peraltro Rāvaṇa è un demone-gentiluomo: la voleva sposare) e qui entra in scena il fuoco per antonomasia, il dio Agni. Un testimonial d’eccezione, visto che egli era, nei sacri Veda, niente meno che il messaggero fra il sacrificante e i Celesti. Eppur non basta: Rāma in cuor suo sarà ben certo della fedeltà della moglie, ma bisogna tener conto delle voci che corrono nel regno, voci di dubbio e d’oltraggio, cosicché Sītā è scacciata, partorisce due gemelli nell’eremo di Vālmīki (considerato per tradizione autore del poema), ancora una volta viene ritrovata ma Rāma, per riaccoglierla, pretende un’altra prova. Sītā stavolta si rifiuta e, invocata la sua Madre Terra, si fa inghiottire nel grembo di lei. Del resto, dalla Terra era nata: Sītā significa “solco” e suo padre l’aveva trovata arando un terreno sacrificale.

“Sii come Sītā” è il tradizionale augurio che si fa alle spose hindū: è lei l’emblema per antonomasia della donna – un modello, e un mito, che gode di ineguagliabile fama, ma non di univoca interpretazione. Sītā, infatti, in più parti del poema tesse l’elogio della pativratā, la donna “che segue i voti verso il marito”, in accordo perfetto con le prescrizioni delle “leggi sacre relative alla donna” (strīdharma): docile, a tutto disposta, fedelissima, pura, bella, obbediente, prolifica, pronta a considerare come un dio anche il più indegno dei mariti. E di questi requisiti – inutile dirlo – Sītā è testimone perfetta. Ma a più tratti, nella sua storia, emergono aspetti del suo carattere tutt’altro che remissivi: esige di seguire Rāma nell’esilio, pretende che il marito catturi una gazzella dal vello d’oro di cui si è incapricciata (e mentre egli è intento alla cattura di quello che in realtà è un demone sotto mentite spoglie, Sītā viene rapita), più volte ammonisce o addirittura redarguisce marito e cognato dimostrando profonda conoscenza della “legge sacra”, alla stregua di un vero e proprio maestro di quest’ultima, il dharma, e infine, non da ultimo, sceglie di farsi riaccogliere dalla Madre, di fatto abbandonando il marito e i figli.
Proprio su queste contraddizioni il pubblico indiano si spacca oggi, per così dire, in tre fazioni: Sītā è un paradigma cui nobilmente adeguarsi poiché lo si ritiene esemplare di un modo di essere hindū e donna nel quadro di una visione tradizionale (e dunque valida in sé) percepita come commendevole; al contrario, Sītā rappresenta un modello retrivo di donna (che si ritiene consapevolmente “cavalcato” dalle frange più oscurantiste del panorama sociale e politico indiano) da ripudiare doverosamente, e, talora, bellicosamente; oppure, infine, è la ribelle che al termine della sua travagliata vicenda – costellata di umiliazioni e dolori – volta infine le spalle all’intera famiglia e soprattutto a un dio-sposo, troppo attento ai doveri di sovrano e troppo cieco dinnanzi a quelli di marito, come sostengono alcune ri-narrazioni moderne del Rāmāyaṇa, che fanno di Sītā l’assoluta eroina, tormentata ma vincente, dell’epica.
Prendere, noi, posizione in materia forse non ha senso o, per meglio dire, è meglio lasciare il verdetto alle donne dell’India: ciò che conta è che Sītā è il mito-modello di una femminilità sempre sottoposta a mettersi in discussione, a dover concretamente provare di essere anche quello che non è, o non ha più voglia di essere, a vivere in equilibrio tra i ruoli “perfetti” imposti dalla tradizione, supportata appunto dai miti, e ruoli più nuovi e inediti.
Si parlava, poco sopra, di asceti. Eroico, ammirato e anche temuto per i poteri acquisiti, la novellistica dell’India classica ci porge spessissimo, a proposito dell’anacoreta (e non senza un tocco di umorismo), un caso emblematico: il valentuomo, pure arroventato da atti di anacoresi (tapas) innumeri e cospicui, frequentemente dinnanzi alle grazie di una donna non resiste. A volte a causa della sua non del tutto sopita debolezza, più spesso tramite l’intervento attivo degli dèi (che si sentono minacciati dalla sua bruciante potenza), allorché gli appare una ninfa celeste, o una semplice donna, di bellezza abbagliante il misero eiacula e perde così, con lo sperma (vīrya), i meriti accumulati con l’ascesi (vīrya, ancora).
Ma naturalmente il peccato è sempre su di lei a gravare, “ambiguo malanno”, fomite per natura di perdizione e, segnatamente, di traviante lascivia; motivo (e mito), questo, a sua volta fondativo, e perciò enfatizzato di continuo, che comporta l’esigenza di custodire attentissimamente la donna in ogni età della vita (non merita mai l’indipendenza, ripetono i testi) e magari, onde evitare che, morto il marito, eserciti le sue malìe su altri, ottima occasione per farne una satī; come dire – da viva, sgualdrina (o potenziale sgualdrina: tutte le donne, è noto, lo sono, se lasciate libere di agire: anche su questo i testi concordano [9] ), da morta “santa”.
Si dice, a buon diritto, che nella tradizione hindū il kāma, la passione, è il solo fine della vita [10] di una donna: se costei è perbene l’eros (insieme con l’obbedienza) fa parte dei suoi doveri verso il marito, l’unico ad aver diritto a goderne in esclusiva, ma se tale non è mette a repentaglio – facendolo letteralmente ardere d’amore – qualunque uomo abbia la disgrazia di capitare sotto le sue grinfie. Che la passione bruci lo dimostra anche il mito di Kāma, il dio d’amore, appunto: per aver cercato di distrarre il dio Śiva dai suoi atti ascetici venne da quest’ultimo incenerito e ridotto a essere Anaṅga, “il senza corpo”. Un mito, questo, che potrebbe suonare come un’ammonizione: guai a chi si faccia colpire da una delle frecce fiorite del Cupido indiano, il quale, in realtà, non rappresenta che il mezzo tramite il quale le donne, che sono “streghe, sia debbano essere ancora sedotte, sia lo siano già state”, [11] riescono a indurre in tentazione anche il più virtuoso, e recalcitrante, degli uomini.
Tutt’altro panorama ci presenta non più la letteratura tradizionale e normativa, ma la “letteratura in stile ornato” (kāvya), e in particolare quella “in forma breve” (laghukāvya): ovvero, la poesia. Quale che sia l’origine, an cora discussa, [12] di questo vasto movimento letterario che trovò le sue opere più insigni e famose tra il II e il XII secolo d.C., un dato è fuori discussione: figure d’assoluto spicco sono quelle femminili (nāyikā, “protagonista”), [13] e desta un qualche sconcerto che in questa sede non appaiano quasi mai sposine fedeli, donne aggiogate alla sudditanza, madri sublimi e straordinariamente prolifiche, bensì femmine alla ricerca d’amore, spesso e soprattutto fuori (o prima) del matrimonio. Seduttive e sfacciate, la poesia ce le mostra alle prese con il fuoco d’amore, e non ci sono limiti alle astuzie e agli stratagemmi che mettono in atto pur di raggiungere l’uomo amato: la poesia indiana, infatti, non conosce amori casti, donne angelicate, passioni che si cullano nel dolce-amaro sentimento della non consumazione o affetti pacati. Per essere felice, l’amore deve giungere al compimento fisico: altrimenti, senza vie di mezzo, è atroce dolore. Ed ecco le spudorate che sgattaiolano fra le viuzze di un villaggio; mogli che impunemente s’incontrano con il loro diletto dopo avere ingannato marito, suocere e cognate; ragazzine all’apparenza virginee che accorrono festanti nei templi – ma di notte – a incontrare l’amante.

Ci piace immaginare che questa corrente letteraria dell’India antica e classica permetta di infrangere il muro solenne della tradizione, popolata di donne succubi, insoddisfatte (o tristemente soddisfatte di una vita d’asservimento), percosse e talora ammazzate; ossia, per usare un termine inadeguato perché moderno, che qualche donna, anche nell’India antica e medioevale, si sia ribellata. E anche se spesso le poesie, per il vero, ci presentano personaggi femminili traditi, affranti o, magari, in amara lotta fra loro per il marito che hanno in comune (una visione forse più realistica della poligamia, presentata ufficialmente come convivenza tra donne felici di servire lo stesso uomo) per lo meno si tratta di dolori scelti e non imposti se non dalle leggi crudeli che quasi invariabilmente coniugano eros e pathos – ma queste ahimè valgono sotto ogni cielo.
Quante donne, nel passato quanto oggi, si siano comportate come le sensuali e spregiudicate nāyikā della poesia non è, naturalmente, dato saperlo; certo è che una cultura misogina e maschilista – e anche questo non è tipico solo dell’India – deve aver sempre lasciato spazio al desiderio di trasgressione, o, quanto meno, all’aspirazione ad appartenere a un uomo non perché imposto dalle esigenze familiari e di casta, ma in base al mito potente dell’amore a ogni costo.
Da questo, forse, deriva un altro fortissimo e non sopito anelito femminile: che l’amore, almeno, possa nascere dopo le nozze, sebbene combinate e non scelte. Come fa giustamente notare lo psicoanalista Sudhir Kakar, sempre e comunque la donna indiana spera nel miracolo della joṛī, [14] la coppia perfetta, che attualizzi sogni di passione e d’unione evidentemente mai spenti: a dispetto d’ogni maltrattamento, d’ogni angheria, delle affollate joint families ove l’intimità coniugale è a dir poco ardua, le spose indiane agognano all’amore e lo cercano disperatamente. [15]
Lo cercano, sì: a costo di rimanerci – è il caso di dirlo – scottate.
NOTE
[1] Si tenga presente che, nell’antichità, la dote costituiva un donativo dei parenti alla figlia e non, come è avvenuto in seguito e oggi ancora accade, un “prezzo” da pagare per poterla maritare. Si vedano per esempio Le Leggi di Manu, III, 51-54.
[2] MANI, pp. 576s.
[3] Noti sono i casi di Roop Kanwar (1987); Charan Shah (1999); Kuttu Bai (2002); Rukhia Devi (2004); Vidyawati Lodi (2006); Janakrani Nazayan (2006); Karuya Devi (2006); Lalmati Verma (2008).
[4] Come ci narrano i celebri testi sull’amore erotico (il Kāmasūtra, per esempio) e i manuali d’istruzione per cortigiane (uno per tutti: la Samayamātṛkā), numerosi nell’India classica, era invece abitudine delle prostitute (e ciò farebbe sorridere se non nascondesse una tragica realtà del mondo coniugale) promettere d’immolarsi se l’“amato” cliente le avesse abbandonate: inutile dire che, spennato il pollo, mai nessuna squillo in sari si bruciò.
[5] Ṛgveda X, 18.
[6] La vittima, di frequente ritrovata in fin di vita o già arsa, non è in grado naturalmente di raccontare come siano andati i fatti; gli assassini hanno tutto l’interesse di far passare l’omicidio per, appunto, “incidente domestico”; persino i genitori della sposa, nel timore di ritorsioni o del disonore che ricadrebbe sulla famiglia, (troppo) spesso tacciono.
[7] Celebre è Ramayan, serie televisiva con la regia di Ramanand Sagar andata in onda, in India, tra il 1987 e il 1988.
[8] Alludo soprattutto a Sita Sings the Blues di Nina Paley.
[9] Esemplare, fra le tante, la seguente sentenza: “Non esiste nulla di più propenso al peccato delle donne; esse […] sono la radice dei mali” (Mahābhārata, XIII, 38, 11; traduzione di chi scrive).
[10] Per “fine della vita [degli uomini]” (puruṣārtha) s’intende per tradizione quel gruppo di obiettivi che il pio hindū d’alta casta dovrebbe seguire: l’amore (kāma, inteso come piacere fisico ma, forse soprattutto, come prosecuzione della famiglia e della casta tramite la generazione di figli maschi); artha (utile pratico, successo derivante dai beni terreni), dharma (“legge sacra”, “religione”, “giustizia”, ordo eterno e immutabile del cosmo e della vita umana) e mokṣa (liberazione dal ciclo delle rinascite (saṃsāra).
[11] Mahābhārata, XII, 43, 22-23 (traduzione di chi scrive).
[12] Rossella 2011.
[13] Rossella 2013.
[14] Kakar 1995, p. 116.
[15] In ciò sono suggestionate, anche, da quella (semi)nuova fabbrica di miti che sono i film commerciali di Bollywood ove, esattamente al contrario di quanto assai spesso accade nella realtà, lo spasimante è sempre integerrimo, fedelissimo, attento ai bisogni dell’amata e disposto a superare ogni ostacolo per conquistarne l’amore purissimo: le torve famiglie che s’oppongono e l’immancabile farabutto che vorrebbe accaparrarsi la bella finiscono malamente scornati, in un tripudio che coniuga giustizia e passione.
BIBLIOGRAFIA
ALBANESE, Marilia, Cinque volti dell’India, foto di Gianluca Borgo e Claudio Tirelli, Milano, Associazione Culturale Obiettivo sul Mondo, 1999.
CAROTENUTO, Aldo, Eros e pathos: margini dell’amore e della sofferenza, Milano, Bompiani, 1987.
KAKAR, Sudhir, Sesso e amore in India, Parma, Nuova Pratiche Editrice, 1995 (Intimate Relations. Exploring Indian Sexuality, Chicago, Chicago University Press, 1989).
KAKAR, Sudhir & Katharina, Gli Indiani. Ritratto di un popolo, Vicenza, Neri Pozza Editrice, 2007 (The Indians. Portrait of a People, New Delhi-New York, Penguin-Viking, 2007).
KṢEMENDRA, La perfetta cortigiana, versione e note di Daniela Rossella, Milano, Editoriale Nuova, 1984.
MANI, Vettam, Purāṇic Encyclopaedia, Delhi-Varanasi-Patna, Motilal Banarsidass, 1975.
Le Leggi di Manu, a cura di
Wendy Doniger con la collaborazione di Brian K. Smith, Milano, Adelphi, 1996 (The Laws of Manu, London-New York, Penguin, 1991).
PIRETTI SANTANGELO, Satī. Una tragedia indiana, Bologna, CLUEB, 1991.
ROSSELLA, Daniela, On the Origins of Kāvya: A Never-Ending Story?, Prague, Publication of Charles University in Prague, 2011.
ROSSELLA, Daniela, I personaggi femminili (nāyikā) nella lirica indiana classica, Parma, L’Oca del Cairo, 2013.
SRINIVASA IYENGAR, K. R., Sitayana: Epic of the Earth-born, Madras, Samata Books, 1987.
VĀTSYĀYANA, Kāmasūtra, a cura di Cinzia Pieruccini, Venezia, Marsilio Editori, 1990.