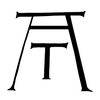di Valentina Meriano
Il teatro è uno tra i luoghi culturali dove la sacralità trova rifugio e manifestazione. Ciò è assodato tanto per le culture del passato quanto per alcune realtà contemporanee che, nonostante l’acquisizione di uno stile di vita improntato su quello occidentale, hanno mantenuto un forte legame tra il mondo del teatro e quello dello spirito. Questo è il caso del teatro nō (lett. “abilità, talento” nell’esibirsi) [1], genere teatrale sviluppatosi in Giappone a partire dal XIV secolo.
Nonostante la sua lunga storia, ancora oggi, gli spettacoli sono fortemente intrisi di una non trascurabile componente spirituale. In modo particolare le maschere indossate dall’attore protagonista, chiamato shite (lett. “colui che fa, che agisce”) [2], sono uno strumento per evocare spiriti e divinità che grazie alla fusione con l’animo dell’attore permettono l’affioramento graduale di passioni celate nella psiche del personaggio e vicende da un lontano passato. Questa caratteristica deriva dalla loro antica origine sacrale. Ancora oggi si crede che: “L’indossare tali maschere […] generalmente porti alla metamorfosi di colui che le indossa in un dio o altra entità soprannaturale, conferendogli potere sovrumano, mentale e fisico”[3].
Per chi crede in questa cooperazione tra attore e divinità, le maschere assumono un’importanza enorme, tanto che vengono apprezzate non solo semplicemente per il loro grande valore artistico ma anche per la loro forte valenza spirituale.
Una in particolare è molto conosciuta e apprezzata per le sue caratteristiche evocative. Si tratta della maschera chiamata Hannya (lett. “Saggezza”).

Gli esemplari più antichi sembrano risalire al periodo Kamakura (1185-1333 d.C.), momento storico che vede la nascita di alcuni tra i più significativi generi teatrali autoctoni. È verosimile che in questo periodo si siano stabilizzate le caratteristiche della maschera, già presenti nella letteratura e nelle arti grazie ad alcune storie che ormai da secoli circolavano. Proprio da queste storie, che uniscono vari aspetti delle credenze popolari e religiose, nasce la maschera come oggi la conosciamo, simbolo di una donna posseduta da ira e gelosia, ma anche da una profonda angoscia.
Questi stati emotivi convivono, entrambi, in Hannya; anche se così diversi, concorrono a creare una sintesi di ciò che il personaggio rappresenta: una donna che è sì posseduta da una grande ira e da una ancora più bruciante gelosia, ma che è anche una donna tradita, profondamente sconvolta e ferita, sorpresa ella stessa dalla forza dei suoi sentimenti, che non le danno pace.
Questa analisi diventa lampante se si guardano, separatamente, il lato inferiore e il lato superiore della maschera. Infatti, domina, nel primo, l’enorme bocca piena di zanne aguzze tipiche di una bestia, una bestia che ha del divino, visto il colore dorato della dentatura, aperta in una contrazione che esprime un’estrema violenza e quindi pronta ad azzannare chiunque si metta sul suo cammino. Nella seconda, invece, gli occhi sono spiritati, fissi, probabilmente, sulla causa della sua trasformazione, anch’essi dorati, ad indicare la piena possessione di uno spirito; i capelli sono scompigliati come quelli di chi è sconvolto, per non parlare delle corna, che da sole richiamano il pericolo e la violenza.
Significativo è, inoltre, il disegno delle sopracciglia, che tracciano una linea inclinata verso il basso, segno inequivocabile di sofferenza. Concentrandosi per un momento su quegli occhi, un osservatore attento può scorgere la profonda agonia di questa donna, in quanto pare quasi sul punto di versare una lacrima ed è disperata per ciò che le è avvenuto, ma, anche, per ciò che accade ora, una situazione di cui, sicuramente, si pente e che vorrebbe finisse immediatamente.
La maschera Hannyafa parte del genere Onryō-men, ovvero degli spiriti vendicativi. Le maschere di questo particolare gruppo sono particolarmente apprezzate per la loro potenza evocativa e per la spettacolarità dei drammi in cui vengono utilizzate.
Si tratta di maschere di demoni, di spiriti, ma soprattutto di esseri umani travolti da violente passioni che li portano a una semi-trasformazione, come nel caso di Hannya.
In questo genere di maschere è evidente tanto la natura umana quanto quella demoniaca. Sono sostanzialmente maschere che rappresentano sì creature non più umane, ma non ancora completamente trasmutate. Come nel nostro caso è palese l’origine umana, indicata da alcuni elementi come l’acconciatura, per le donne, e capelli e barba per gli uomini; alcuni esemplari che rappresentano delle dame di corte portano ancora i segni del trucco.
Mentre la parte demoniaca si palesa tramite gli occhi sbarrati e solitamente dorati, simbolo tipico degli spiriti; in alcuni casi le ossa del volto sono molto sporgenti, forse a suggerire una precedente morte del personaggio; come nel caso di Hannya spuntano canini prominenti, più simili a quelli di un animale predatore piuttosto che di un essere umano, insieme a un paio di corna. Quando questi due ultimi elementi sono presenti anch’essi sono di colore dorato per palesare la nascente possessione demoniaca.
Hannya viene utilizzata in diversi drammi, ma solo in quattro viene usata nel ruolo di protagonista: Aoi no ue, Dōjōji, Momijigari e Adachigahara.
La vicenda narrata in Aoi no ue (La Dama Aoi), tratta dal Genji monogatari (composto nel XI secolo dalla dama di corte conosciuta come Murasaki Shikibu), racconta l’avvenimento nel quale lo spirito vivente della Signora di Rokujō uccide la principessa Aoi. Il dramma si apre con l’entrata in scena di un vassallo che spiega lo stato di malattia, apparentemente incurabile, della principessa Aoi: nel tentativo di guarirla viene chiamata una sciamana, che con le sue preghiere riesce a evocare lo spirito che tormenta la principessa. Si manifesta dunque la Signora di Rokujō su un carro devastato, spiega il motivo del suo rancore verso la rivale e cerca di portarla via con sé. Viene chiesto l’intervento di un monaco, lo spirito di Rokujō si manifesta nuovamente, si batte con il monaco, ma di fronte alle sue potenti formule e alla recitazione dei testi sacri buddhisti, stremata, si placa e, gioendo per la sua liberazione, se ne va risparmiando la vita della principessa Aoi.

Il dramma Dōjōji mette in scena una storia tratta da un episodio narrato nella raccolta Konjaku monogatari (“Racconti del tempo che fu”), composta presumibilmente agli inizi del XII secolo da autore ignoto. La vicenda si svolge in un tempio, nel giorno di inaugurazione di una campana. Sul luogo improvvisamente giunge una danzatrice, che chiede di poter vedere la campana. Il custode in un primo momento la respinge, ma poi la lascia entrare domandandole di danzare. La danza si fa sempre più frenetica, finché la donna non manifesta il suo risentimento verso la campana, e, con un balzo, si nasconde sotto di questa, che improvvisamente cade. A questo punto il monaco abate racconta la storia della donna serpente, la quale innamoratasi di un giovane monaco, che non la contraccambiava, giunse a tramutarsi in serpente gigante per poi uccidere il monaco dando fuoco alla campana sotto cui si era rifugiato nel tentativo di salvarsi. I monaci a questo punto iniziano a pregare quando da sotto la campana appare lo spirito serpente che affronta i monaci ma alla fine viene placato dalle loro preghiere.

Il dramma Momijigari (“A caccia di aceri”) rievoca le leggende dei monti di Shinano, luoghi dimora di demoni, dove il leggendario Taira no Koremochi (vissuto, secondo il mito, nell’XI secolo), famoso per essere un prode guerriero e annientatore di demoni, ne affronta e uccide uno. Da principio appare una dama con le sue accompagnatrici, recatesi sulla montagna per ammirare lo spettacolo degli aceri scarlatti. Quando giunge Koremochi con i suoi compagni, impegnati in una caccia al cervo, le dame li convincono a restare con loro per banchettare, gli uomini accettano e ben presto vengono colti dal sonno, mentre le fanciulle iniziano a danzare, fino a che un vento di tempesta scuote le chiome degli aceri. Nel sonno Koremochi incontra la divinità Takeuchi che lo mette in guardia sulle dame, essendo esse in realtà dei demoni della montagna pronti a ucciderli. La divinità consegna una spada magica al guerriero, che subito si desta per affrontare la dama riapparsa come demone: i due combattono ma Koremochi riesce ad avere la meglio e ad ucciderlo.

L’ultimo dramma è Adachigahara (“La piana di Adachi”), così chiamato dalla scuola Kanze, una delle cinque scuole che si tramandano attraverso il capofamiglia il ruolo di shite; le altre scuole usano il titolo Kurozuka (“La tomba nera”). Il dramma si apre con l’arrivo nella piana di un monaco e dei suoi due compagni, i quali, sorpresi dalla notte, chiedono ospitalità ad una anziana donna che vive sola nell’unica capanna della zona. Su richiesta del monaco l’anziana mostra ai tre il metodo di filatura con l’arcolaio; nell’operare questo gesto ossessivo racconta quanto sia triste e desolante vivere sola in un luogo così isolato, finché si abbandona al pianto. Sorprendentemente si riprende subito, dicendo ai visitatori di doversi assentare per andare a cogliere della legna; esce dunque di casa, avvertendoli, però, di non guardare nella sua stanza. Uno degli accompagnatori del monaco non resiste alla curiosità e, con l’orrore dei suoi compagni, scopre un cumulo di ossa e resti umani. Mentre cercano di fuggire, la donna torna in veste di demone e li assale mentre si scatena una tempesta. Il monaco riesce a farla desistere solo con la forza delle sue preghiere.

Questi quattro drammi fanno rispettivamente parte del “quarto tipo” (Aoi no ue, Dōjōji) e del “quinto tipo” di nō (Momijigari, Adachigahara). Una prima elaborazione di questi “tipi” venne teorizzata da Zeami Motokiyo (c. 1363 – c. 1443) nei suoi trattati, scritti tra il 1400 e il 1429. Sono gli scritti sulla teoria teatrale più interessanti dell’epoca. Riscoperti solo agli inizi del XX secolo, hanno permesso di studiare aspetti del teatro nō che restavano ancora oscuri. I trattati toccano svariati argomenti: dalla formazione dell’attore alla messa in scena dei vari “tipi” di drammi, dalla scrittura drammatica alla componente musicale, dalla danza alla gestualità, dall’estetica del linguaggio ai metodi di enunciazione. Ma soprattutto Zeami ricorda costantemente l’importanza della comunicazione tra il pubblico e l’attore.
Il “quarto tipo” di drammi comprende i nō di follia, di vendetta, di racconti cinesi, di passioni e di racconti contemporanei; mentre quelli del “quinto tipo” includono i drammi di creature soprannaturali, come demoni e creature fantastiche. Questi due tipi venivano collocati in chiusura del gruppo di cinque rappresentazioni che componevano una “giornata di nō”, pensata per tenere sempre vivo l’interesse dello spettatore, che nei tempi antichi assisteva agli spettacoli per un’intera giornata. Il quarto e il quinto tipo avevano lo scopo di riaccendere l’interesse dello spettatore con ritmi più sostenuti, storie più avvincenti e personaggi contrassegnati da un forte impatto visivo.
Detto questo è facile capire perché i drammi di Hannya fanno parte di queste categorie: sono spettacoli tragici, dove la fantasia dello spettatore è fortemente stimolata dalla vista del personaggio demoniaco con la maschera, dalle fattezze tanto feroci quanto disperate, con il costume decorato con il motivo uroko haku [4], composto da un disegno geometrico triangolare, ripetuto in oro e argento, che trasmette tutta la fredda squamosità del serpente. La lotta con il monaco e la successiva liberazione dello spirito della donna fanno di questi drammi un’opera senza tempo e coinvolgente, tanto sul piano visivo quanto su quello emotivo.
Naturalmente nei quattro drammi sopraelencati non viene utilizzata solo la maschera di Hannya: innanzitutto rappresenta uno stadio di possessione quasi completa, quindi, come abbiamo visto, non si adatta ai personaggi fin dall’inizio, quando hanno ancora sembianze umane; secondariamente questa maschera possiede un’espressività troppo forte per poter essere usata per tutta la durata dello spettacolo; infine gli attori stessi affermano che la potenza evocativa di Hannya è troppo impegnativa da sostenere per tutto il tempo.
Solitamente si utilizza un’altra maschera prima di indossare Hannya, ovvero la Deigan (lett. “occhi d’oro”). Questa maschera rappresenta una dama di alto rango, che però manifesta già i primi sintomi di una possessione, attraverso gli occhi di colore oro e le pagliuzze dorate che circondano l’arcata sopraccigliare. Questa maschera è caratterizzata da un’espressione già carica di gelosia e rabbia, ma possiede anche caratteristiche che suggeriscono un alto grado di sofferenza; le scaglie dorate fanno spesso pensare a un volto umido di pianto, segno che questa donna prova dolore, oltre che rabbia.

La Deigan è sapientemente costruita per trasmettere sentimenti contrastanti, ora di angoscia, ora di ira. Tutto ciò avviene grazie ad alcune caratteristiche strutturali le quali, in base all’angolazione della stessa maschera rispetto alla fonte di luce, permettono l’affioramento di un sentimento piuttosto che di un altro.
Questa maschera potrebbe quindi, a ragione, fare parte del gruppo delle Onna-men, ovvero le maschere di donna, che rappresentano fanciulle, donne mature e anziane, dato che la Deigan contiene tutti i tipici tratti di questa categoria, raffigurando una dama di alto lignaggio del periodo Heian, con l’acconciatura tipica dell’epoca, le sopracciglia rasate e ridipinte più in alto e, infine, il chiarore del volto. Purtroppo, gli occhi e i denti dorati ci suggeriscono già la presa che la gelosia ha sul cuore della donna, portandola verso un primissimo stadio di possessione. Altri elementi, però, la allontanano dalle maschere Onna, e soprattutto, da quelle di giovani donne (Ko-omote, lett. “viso grazioso, adorabile), generazione a cui appartiene anche la Deigan. Infatti, se le prime infondono un senso di pace, sprigionato dai lineamenti sereni appartenenti a fanciulle non ancora colpite dalla vita, la seconda riflette tutta la sofferenza di chi vive un profondo dramma interiore.

Sulla scena la Deigan trasmette sensazioni molto forti, grazie a un sapiente uso delle zone di luce e ombra: con il movimento della maschera da parte dell’attore verso il basso, la forma accentuata della fronte e dell’arcata sopraccigliare creano una zona d’ombra sugli occhi che le conferisce un senso di dolore, di pianto, accentuato anche dai frammenti di pigmento dorato, che richiamano il luccichio delle lacrime. Indizi che il personaggio, forse, riesce a cogliere ciò che sta diventando, e se ne rammarica.
Un ulteriore elemento rivelatore della lotta interiore della Deigan, è rappresentato dalla forma della bocca, aperta e piegata verso il basso che, tramite un leggero movimento in avanti dell’attore crea l’illusione che la bocca voglia spalancarsi per ghermire la sua vittima, accentuando nel contempo la sensazione di rabbia celata dagli occhi.
Se la Deigan rappresenta uno stato precedente a quello di Hannya, un’altra ne impersona tutta la forza distruttiva di creatura ormai lontana dall’essere umano e completamente mutata in demone vendicatore. Questa maschera è chiamata Ja (lett. “Serpente”).

Realizzata e tramandata dai capofamiglia della scuola Kongō, Ja è lo stadio finale della possessione demoniaca, tanto che viene inserita nel gruppo delle maschere Kishin (lett. “Divinità”) [5].
Le appartenenti a questa categoria sono maschere dalle espressioni molto marcate, con palesi elementi sovrannaturali, come il colore della pelle che varia dal rosso, al nero, al giallo, persino all’oro; sono presenti denti animaleschi e sporgenti, corna, insomma queste maschere possono davvero rappresentare qualunque tipo di essere divino, o nel nostro caso una creatura ormai fuori dall’universo umano.
Vedendola non si può non rimanere colpiti. È una maschera di grande impatto visivo, simile per certi aspetti ad Hannya, come per le corna, la dentatura e gli occhi dorati, ma allo stesso tempo è palese l’evoluzione verso il demoniaco, poiché Ja possiede un’espressione ancora più furiosa, il dolore presente negli occhi di Hannya qui è quasi completamente sparito per lasciare spazio ad un più selvaggio furore. L’espressività della bocca spalancata viene ulteriormente accentuata e il colore del volto non è più bianco ma è ormai quasi completamente rosso. L’unica traccia che resta della donna umana è l’accenno di acconciatura sfatta che ancora circonda le corna. Ja viene solitamente utilizzata nei drammi Dōjōji e Momijigari.
Oltre alle maschere, che indubbiamente ricoprono un ruolo fondamentale nei drammi nō, sono anche estremamente importanti altre componenti che fanno dei quattro drammi sopraelencati alcuni tra i più apprezzati e conosciuti.
Uno tra questi è la danza. Nel teatro Nō, infatti, la danza (Mai, dal verbo Mau lett. “ruotare” o “girare intorno”) [6] è uno degli elementi fondamentali, insieme alla musica e al canto, pensiero già espresso da Zeami nei suoi trattati, secondo cui questi erano la vera essenza dello spettacolo [7]: lo stesso Zeami fa risalire le origini della danza nō all’episodio della dea Amenouzume no mikoto, e alle danze rituali del kagura [8].
Generalmente le danze nō consistono in una concatenazione di movimenti, atti non tanto a far risaltare, come accade in altre arti, l’elemento acrobatico, quanto piuttosto a proiettare verso l’esterno il processo interiore che si sviluppa nel personaggio nel corso dello spettacolo, attraverso movenze intense ma controllate.
Anche qui ritroviamo le due categorie di cui fanno parte le maschere, ovvero: gli spiriti vendicativi (Onryō) e i demoni e le divinità (Kishin). La sostanziale differenza tra i due gruppi risiede nel fatto che i primi possiedono l’aspetto di una creatura sovrumana, conservando, ancora, una mente umana; mentre i secondi fanno completamente parte del mondo dell’oltre umano. Questa differenza si riflette nello stile: nei primi non vi è necessità di movimenti violenti, anche se si utilizza già il termine hataraki ( lett. “movimento forzato”), riscontrabile nel battito del piede, tipico di questi personaggi; inoltre la danza di questo gruppo è contrassegnata da movimenti che riflettono lo stato a metà strada tra l’umano e il sovrumano, perciò vi è sempre un certo controllo, il personaggio non si è ancora totalmente abbandonato alla natura demoniaca, e di conseguenza anche la danza non può lasciarsi andare a slanci incontrollati. Nei secondi lo stile hataraki viene spinto all’estremo, con movimenti dominati dalla violenza, dove ogni eleganza è esclusa: questo genere di movimento deve riflettere la mente di un personaggio non umano e, nel caso dei demoni, anche attanagliata da sentimenti turbolenti, che si manifestano con una danza frenetica, molto coinvolgente per lo spettatore.
Vi è anche un particolare movimento appartenente alla maschera Deigan capace di colpire e commuovere lo spettatore per la sua grande bellezza, ovvero, lo shiori kata (“posizione del pianto”). L’attore assume una posa che esprime una profonda tristezza: il braccio destro, che solitamente regge un piccolo oggetto, come un ventaglio, si pone lungo il corpo, e, simultaneamente, il busto si incurva in avanti, seguito dalla testa, mentre il braccio sinistro va a coprire la parte bassa della maschera, come a nascondere una smorfia di dolore. Questa posizione rispecchia tutta la sofferenza che attanaglia il personaggio, il quale sembra quasi piegarsi sotto il suo peso opprimente, mentre l’espressione assunta dalla maschera suggerisce un pianto, che se pur scaturito da emozioni molto violente, si mantiene controllato.
Inoltre, la danza che caratterizza la Deigan è estremamente coinvolgente, ed è composta da movimenti carichi di tensione, dove la furia del personaggio si riversa all’esterno. In tale specifico caso, infatti, si alternano, con facilità, momenti di grazia a momenti di pura violenza, scanditi da ritmi incalzanti, che riflettono il tumulto interiore dell’entità. Si tratta di danze molto eccitanti per lo spettatore, che assiste alla duplice lotta del personaggio, sia interiore contro se stesso, che esteriore contro l’avversario, spesso un monaco che incarna le forze benevole del mondo.
Con la maschera Hannya invece le movenze si spostano più verso lo stile delle Kishin. Tuttavia Hannya, anche se può sembrare priva di grazia, di bellezza e di intensità, in realtà nasconde delle sorprese. L’incanto sottile [9], infatti, lo si trova soprattutto qui, dove le sofferenze della vita hanno colpito con maggior violenza il personaggio.
Il talento di un attore è messo a dura prova con personaggi così complessi e carichi di potenzialità; infatti, chi assiste ad uno spettacolo con protagonista Hannya, se l’attore ne è in grado, resta folgorato dalla potenza estetica da essa sprigionata, laddove lo spettatore si aspetterebbe solo bruttezza e orrore.
Ultimo indispensabile elemento che contribuisce al successo di Hannya è costituito dal simbolico uso dei colori, tanto nelle maschere quanto nei costumi.
Per quanto riguarda i costumi sappiamo dai trattati di Zeami che egli era contrario ad un uso eccessivo di costumi preziosi, in quanto, a suo parere, sarebbe stato più stimolante ispirarsi alla realtà, alla maniera con cui un personaggio avrebbe potuto essere abbigliato secondo il proprio stato sociale. Oltre a questo, i costumi dovevano avere la capacità di riflettere lo stato interiore del personaggio, probabilmente, attraverso l’uso di determinati simboli, tonalità e tessuti; tuttavia le sue idee, in questo ambito, non furono molto ascoltate.
Dalle testimonianze dell’epoca si rileva che i tessuti usati erano di fattura molto pregiata e preziosa, questo, per due scopi in particolare: innanzitutto per compiacere gli dei, e, secondariamente, per meravigliare gli spettatori. La scelta di usare questo genere di costumi dipendeva anche da un’usanza tipica dell’epoca, chiamata kosodenugi: gli aristocratici, in segno di gradimento per la buona riuscita dello spettacolo o per la bravura di un certo attore, si toglievano un proprio capo di abbigliamento e glielo donavano [10]. Grazie a questa tradizione gli attori del primo teatro nō poterono usufruire di costumi splendidi, che altrimenti non avrebbero potuto permettersi, essendo composti da tessuti molto pregiati, e, spesso, importati dal continente, come, per esempio, il broccato di seta dorato.
Con il trascorrere del tempo, tuttavia, alcune idee di Zeami si imposero sulla scelta dei costumi da parte dell’attore, che deve necessariamente sceglierlo in base alle caratteristiche del personaggio. Inoltre, il costume oltre ad adattarsi al tipo di personaggio che si porta in scena, deve, attraverso l’uso dei colori e delle decorazioni, evocare lo stato d’animo del personaggio, e armonizzarsi con l’atmosfera generale della rappresentazione; quindi, i motivi decorativi, sia dipinti che ricamati, devono essere adatti alla stagione nella quale si svolge il dramma e, devono essere adatti al luogo [11].
Ad esempio, nel nostro caso, per il dramma Momijigari, lo shite sceglie di indossare un costume dalle tonalità vermiglie o dorate, con decorazioni a foglia d’acero, ventagli, fiori di crisantemo, e tutti quei simboli associati all’autunno.
Similmente lo shite che interpreta la Signora di Rokujō nel dramma Aoi no ue, nella prima parte, quando ancora indossa la maschera Deigan, è chiamato a optare per un costume che richiami il rango sociale e la bellezza della donna, ancora piuttosto giovane, quindi il costume potrebbe avere un fondo rosso, colore attribuito alla giovinezza, o dorato, a indicare il rango sociale del personaggio, o, ancora, con motivi floreali, a richiamare la bellezza, poi farfalle, disegni geometrici, uccelli, tutti attributi che ci si aspetta di vedere associati a una bella donna di alto rango.
Per quanto riguarda la scelta dei colori, uno in particolare, il rosso, si ritrova spesso nei drammi di Hannya, sia ad indicare l’età che denota una persona giovane, sia la furia del demone. Non dimentichiamo, però, che il rosso è considerato anche un colore sacro, associato al Sole e quindi alla vita. Ecco che ancora si presenta la dualità della maschera e del personaggio, la sua doppia natura: da un lato, rappresenta le paure più profonde dell’essere umano, mentre dall’altro funge da spauracchio contro il male.
Oltre al rosso, ai personaggi che utilizzano la maschera di Hannya vengono spesso abbinati il colore oro e il colore argento, entrambi associati al sovrannaturale, specialmente nel momento in cui il demone si palesa. Questo perché l’oro e l’argento sono associati al mondo sovrumano, perciò si adattano perfettamente ad un demone. In particolare li troviamo nel motivo decorativo chiamato uroko haku, che attraverso una fantasia a triangoli richiama le squame del serpente.
Solitamente questo motivo si intravede dalla scollatura del karaori (lett. “tessuto cinese”) [12], tipo di veste confezionata con un pesante broccato, di fattura simile ai kimono moderni, e non viene completamente nascosto proprio per suggerire l’imminente trasformazione. Generalmente il karaori viene usato per i ruoli femminili, indossato sopra ad altri indumenti, e ne esistono due tipologie: iroiri (“con rosso”) usato dalle giovani donne, e ironashi (“senza rosso”) indicato per le donne anziane [13].
Il motivo uroko haku si trova solitamente su un tipo di veste chiamata surihaku, composta da un tessuto molto leggero di seta, generalmente bianca per far risaltare il motivo geometrico, a volte in oro o argento, e a volte, in rosso [14]. Anche se solitamente il motivo uroko haku lo si trova su campo bianco, esistono alcune versioni su campo rosso [15].
Il motivo “a squame” è di grande impatto, non soltanto perché rievoca una creatura temuta e pericolosa, ma anche perché sembra reagire all’impeto crescente del demone, soprattutto nei momenti di danza-lotta contro il monaco, o il guerriero a seconda dei casi.
Sempre rossa è anche la parte inferiore del costume, costituita da una gonna ampia con ripiegatura centrale, che la rendono simile a un pantalone; questa è chiamata hakama, e, solitamente, questo modello si trova sempre in tinta unita. La scelta di usare un capo di abbigliamento fittamente decorato, il surihaku, e uno completamente spoglio, possono voler simboleggiare la doppia natura dell’entità, sia donna che demone.
Tenendo conto di queste norme, l’attore ha comunque la possibilità di fare piccole variazioni; ad esempio può scegliere, per la parte inferiore, al posto dell’hakama in tinta unita, un modello con decorazioni più o meno sfarzose.
La stessa importanza attribuita al colore di tutte le componenti del costume è riscontrabile anche nelle maschere. Abbiamo visto, infatti, come le fasi di “evoluzione” di Hannya portino, progressivamente, dal bianco della maschera Deigan al rosso della Ja.
Le varie tonalità vengono utilizzate per indicare il livello di possessione della donna, la quale, se in un primo momento fa ancora parte del mondo umano, pur rivelando già una certa presa da parte del demone tramite l’uso del pigmento dorato, viene trascinata sempre più verso la dimensione demoniaca.
La maschera che meglio riflette il transito della trasformazione è Shiro Hannya (lett. “Hannya bianca”) [16]; di questa maschera, infatti, si possono trovare esemplari di diversi colori, in base al livello raggiunto dalla furia della donna, iniziando dal bianco, usato solitamente nei drammi Aoi no ue o Adachigahara, passando per il giallo, presente nel dramma Momijigari, per giungere, alla fine, al rosso, usato, per lo più, nell’ultima parte del dramma Dōjōji, dove la presa del demone è totale.
Naturalmente, come avviene con i costumi, la maschera viene scelta dallo shite, perciò è a sua discrezione stabilire quale maschera con la giusta tonalità vada usata, in base al suo sentire personale e a quello del personaggio, che, non dimentichiamo, discende nello shite per guidarlo nella rappresentazione.
Valentina Meriano si è laureata in Scienze della Musica e dello Spettacolo presso l’Università degli Studi di Milano con una tesi intitolata “Hannya: il mito della donna serpente tra passato e presente”, relatore prof.ssa Rossella Menegazzo, correlatore prof. Alberto Bentoglio.
NOTE
[1] Ortolani Benito, Il teatro giapponese, dal rituale sciamanico alla scena contemporanea, Bulzoni editore, Roma, 1998, p.75
[2] Sieffert Renè (a cura di ), Zeami Motokiyo, Il segreto del teatro Nō, Adelphi edizioni, Milano, 2009, p.20
[3] Omote, le maschere del teatro Nō, catalogo della mostra a cura di D. Crovella, C. Russo, Edizioni Yoshin Ryu, Torino, 2009, p.87
[4] Calza Gian Carlo, Il fiore del demone, L’incanto sottile del dramma Nō, Editoriale Nuova, Milano, 1983, p.55
[5] Omote, le maschere del teatro Nō, catalogo della mostra a cura di D. Crovella, C. Russo, Edizioni Yoshin Ryu, Torino, 2009, p. 15
[6] Cit. in Ruperti Bonaventura, Scenari del teatro giapponese, Libreria Editrice Cafoscarina, Venezia, 2016, p.16
[7] Sieffert Renè (a cura di ), Zeami Motokiyo, Il segreto del teatro Nō, Adelphi edizioni, Milano, 2009, p.13
[8] L’origine del termine “kagura” è ancora oggi molto discussa dagli studiosi, tuttavia in generale viene identificata con un genere di intrattenimenti, che possono essere molto diversi tra loro, atto ad invocare la benevolenza di una divinità. La traduzione più comunemente accettata è “musica degli dei” o “posto della divinità”, derivante dall’utilizzo che ancora oggi le viene attribuito. Cfr. Ortolani Benito, Il teatro giapponese, dal rituale sciamanico alla scena contemporanea, Bulzoni editore, Roma, 1998, pp. 31-32
[9] Traslazione non corretta, ma accettata, del termine yūgen, composto dai caratteri traducibili con “mistero” e oscurità”. Coniata da Renè Sieffert nel 1963, per il testo “Zeami Motokiyo, Il segreto del teatro Nō”. Di origine cinese, il termine viene introdotto e utilizzato in Giappone nel X secolo per esprimere la particolare raffinatezza ed eleganza di un opere letterari. Zeami se ne appropria e lo adatta ai testi e alle rappresentazioni Nō. Nel corso della sua vita modificherà la sostanza del termine, infatti nei suoi primi scritti il termine veniva attribuito ad uno spettacolo capace di suscitare una bellezza colma di grazia, mentre nel periodo più tardo indica una combinazione di eleganza, intensità e aspirazione alla verità cosmica. Alla fine della sua carriera il significato del termine muterà ancora, simboleggiando una bellezza malinconica, ovvero, tanto più un personaggio rappresenta la condizione per cui l’uomo soffre a causa di forze più grandi di lui, tanto più si avvicina alla bellezza data dall’impermanenza dell’uomo nella realtà visibile.
[10] Il Giappone fra passato e presente, il recupero dei metodi tradizionali di manifattura nei costumi del teatro nō, catalogo della mostra a cura di Di Mattia Luigina, Sillabe della Cooperativa Livorno: Nouvelles Frontières, Livorno, 1993 p.24
[11] M.L., Ibidem, p.37
[12] Calza Gian Carlo, Il fiore del demone, L’incanto sottile del dramma Nō, Editoriale Nuova, Milano, 1983, p.54
[13] Teatro Nō, costumi e maschere, catalogo della mostra, testi a cura di Ortolani Benito, Istituto giapponese di cultura, Roma, 1971, p.77
[14] Calza Gian Carlo, Il fiore del demone, L’incanto sottile del dramma Nō, Editoriale Nuova, Milano, 1983, p.55
[15] Teatro Nō, costumi e maschere, catalogo della mostra, testi a cura di Ortolani Benito, Istituto giapponese di cultura, Roma, 1971, p.79
[16] Omote, le maschere del teatro Nō, catalogo della mostra a cura di D. Crovella, C. Russo, Edizioni Yoshin Ryu, Torino, 2009, p.138.