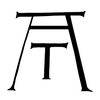Oppresso dalla sofferenza e dall’insofferenza nei confronti del limite, il mondo indiano ha elaborato diverse modalità d’approccio e di risoluzione del problema. Uno dei comuni denominatori nel complesso e antichissimo universo culturale dell’India è la convinzione che l’ignoranza sia alla radici di tutti i mali. Un’ignoranza che offusca la visione della realtà, inquina i pensieri e condiziona le azioni in un circolo vizioso e doloroso: la commedia umana è una rappresentazione fallace.
L’arte scenica indiana antica può dunque essere vista come la ricerca di un linguaggio sottile e allusivo che riformuli le espressioni della mente, del corpo e della parola, in vista di una diversa rappresentazione dell’esistenza. La trama che la costituisce viene ritessuta in modo paradigmatico, affinché l’arazzo prodotto manifesti ciò che deve essere a tutti i livelli e in ogni campo.

La genesi del teatro indiano è difficilmente ricostruibile e, stando ai reperti archeologici e alle testimonianze letterarie, le prime manifestazioni sembrerebbero risalire addirittura al secondo millennio prima della nostra era. Secondo il mito, l’arte dello spettacolo sarebbe stata ideata da Brahmā [2] , l’artefice del mondo, a cui gli dei si erano rivolti affinché elaborasse un tipo di divertimento istruttivo, in grado di promuovere diletto per l’udito e la vista, e dunque accessibile anche agli uomini più semplici. Brahmā aveva allora attinto dai quattro “Veda”, i primi testi sacri della cultura indiana ascritti al secondo millennio a.C., prendendo dal “Rigveda” la parola, dal “Sāmaveda” la musica, dallo “Yajurveda” la mimica e dallo “Atharvaveda” i sentimenti. Era stato così compilato un quinto “Veda”, il “Nāṭyaveda” cioè il “Veda dell’arte drammatica”, adatto ad elevare il genere umano, incapace di più sottili e metafisiche ricerche, per incamminarlo sulla via della salvezza. Reputando fondamentale inserire la partecipazione femminile, Brahmā aveva istruito le apsara, le ninfe celesti, a fare da attrici e danzatrici.
Di questo mitico “Nāṭyaveda” il saggio Bharata, nebuloso personaggio ascritto ai primi secoli dell’era cristiana (II/III sec. d.C.), ne avrebbe fatto un adattamento ad uso dei mortali: il “Nāṭyaśāstra”, “Trattato d’arte drammatica”[3], il cui commento principale, l’Abhinavabharati, si deve ad Abhinavagupta nel X sec.
Al di là delle origini mitiche, il teatro sembra essersi sviluppato in ambito rituale e dunque addirittura in epoca vedica, centrata proprio sul rito, in quanto strumento ottimale per controllare le energie cosmiche, ovvero gli stessi dei. Le complesse operazioni condotte dai brāhmaṇa, i detentori della scienza sacra, agivano su più livelli: nell’ambito del microcosmo, ovvero nella sfera umana, e in quello del macrocosmo, cioè nell’universo, e le loro ripercussioni investivano le diverse reti di rapporti che gli uomini intrecciavano con i propri simili, con la natura, con gli dei, con l’Assoluto. In tal senso il Veda può essere definito come multi scenico.
Il rito è la riproduzione regolata di un evento, con una persona che interpreta un ruolo codificato, pronunciando parole e compiendo gesti convenuti volti alla realizzazione dello scopo prefisso. La rappresentazione teatrale inscena una sequela di accadimenti, impiega personaggi che recitano ruoli prefissati, avvalendosi del linguaggio verbale e corporeo, con il fine di istruire divertendo.
Ma se il teatro è rituale, in che misura rappresenta la vita? E, soprattutto, in che misura la vita è “reale”? Il mondo indiano ha sempre affermato che la realtà così come la vedono gli uomini è illusoria, relativa e sempre percepita in maniera soggettiva e non oggettiva. E’ māyā, termine complesso che significa al tempo stesso “misurazione” (il mondo per venire all’essere deve definirsi nello spazio e nel tempo) e “erronea visione” nutrita dai preconcetti e dalle aspettative dei singoli. Interessante notare a questo proposito che il sipario si chiama tiraskariṇī, “che dissimula”; il termine definisce anche il velo delle apsaras, usato dalle ninfe celesti per occultare il loro essere. L’alzarsi del sipario alluderebbe allora al dissiparsi dell’illusione e dell’ignoranza, poiché le vicende rappresentate sul palcoscenico costituiscono situazioni paradigmatiche a cui ispirare il comportamento[4].
Il teatro si prefigge di istruire divertendo e precisamente di insegnare il dharma facendo al tempo stesso gustare la beatitudine del Brahman[5]. L’azione scenica è “una poesia che si vede”[6], in quanto dà forma ai concetti[7] ed è metafora della realtà. Grazie ad essa si rendono visibili gli effetti delle azioni (karman) e si esemplifica come il sistema castale (varṇa) e la sua struttura gerarchica[8] garantiscano l’ordine e la giustizia sociale. I ruoli teatrali insegnano che il diverso comportamento è determinato dall’essere nati uomo o donna e dal trovarsi in una o nell’altra stagione della vita (āśramadharma)[9] ed è finalizzato alla realizzazione dei quattro scopi fondamentali dell’esistenza (puruṣārtha): il dharma, il complesso di norme che reggono ogni forma e aspetto dell’essere, l’artha, cioè l’utile materiale, il kāma, la realizzazione del piacere e il mokṣa, la liberazione dal saṃsāra, il doloroso cerchio delle rinascite.
La prima mitica rappresentazione messa in scena da Brahma celebrava la vittoria di Indra, re degli dei, sugli asura, i demoni che minacciavano il mondo. Costoro, irritati per la pessima figura che facevano in scena, sfidarono Brahmā ma questi, impugnata la bandiera di Indra, la piantò sul palcoscenico per rimettere al loro posto i riottosi signori delle tenebre. A tale evento si collega la cerimonia dell’installazione del pennone sulla scena dei teatri degli uomini, pennone al quale erano dedicate alcune cerimonie.
Dai testi sappiamo che tali luoghi erano strutturati in tre parti: nepathya, retroscena o camera del trucco; rangapīṭha o rangaśīrṣa, palcoscenico; rangamaṇḍala, platea. Di tali costruzioni – in materiale deperibile – nulla è rimasto, ma i padiglioni ancora in uso per le rappresentazioni teatrali nei templi del Kerala, i kutambalam, benché non molto antichi, ereditano le forme di quelli dei primi secoli della nostra era.
Il teatro può essere lokadharmi, ovvero “popolare” nel senso di realistico, e nāṭyadharmi, cioè “rappresentazione scenica” e quindi convenzionale. E’ soprattutto di quest’ultima forma che si occupa il “Nāṭyaśāstra”. In esso vengono esposti i principi fondamentali della messa in scena e di tutte le arti che hanno pertinenza con il teatro, e cioè la danza, la mimica, la musica e la dizione.
L’arte scenica si avvale di quattro mezzi fondamentali: l’espressione corporea (angīka), quella vocale (vācika), l’apparato scenico che include i costumi e il trucco (aharya), la rappresentazione dei sentimenti e degli stati d’animo (sattvika).
Per quanto riguarda l’espressione corporea, può essere di tre tipi:
* nṛtta, danza pura, astratta, decorativa
* nṛtya, danza con movimenti significativi, sorta di pantomima che rappresenta un evento
* nāṭya, espressione drammatica di un racconto tramite le parole e un rigoroso vocabolario codificato di gesti, abhinaya (abhi “verso” e ni “portare”), che viene usato per sottolineare la rappresentazione di emozioni e stati d’animo.
I personaggi principali dei drammi indiani, che possono includerne fino a ventotto, sono:
* il sūtradhāra, “colui che regge i fili” ed è regista, impresario e attore al tempo stesso. Compare nel prologo, spesso affiancato dalla prima attrice, ed ha il compito di introdurre il dramma, presentandone l’autore e la trama. Il termine sūtradhāra si applica anche all’architetto, poiché sūtra vuole dire “filo”, strumento indispensabile per prendere e definire le misure: il regista dunque “costruisce” lo spettacolo, è colui che tiene le fila. Evidente il rimando alle marionette mosse dal burattinaio. Sūtra viene anche impiegato in ambito letterario per designare un testo articolato in aforismi, che costituiscono il filo conduttore del discorso.
* l’eroe principale, nāyaka, dotato di tutte le virtù.
* l’eroina, nāyikā, anch’essa di eccelse qualità.

* il buffone, vidūṣaka, spesso deforme, amico del protagonista[10]. Pur essendo un brahmano, è un personaggio buffo, goffo e trasgressivo, che parla in pracrito, la lingua locale, invece che in sanscrito, e che costituisce una sorta di ponte fra i raffinati privilegiati della corte e delle caste superiori e la gente comune.
* l’antieroe, pratināyaka, caratterizzato dalle peggiori qualità.
* l’antieroina, pratināyikā, anch’essa totalmente negativa.
* il viveur parassita, viṭa, spesso parente dell’eroe.
Proprio per il suo carattere didattico il teatro è paradigmatico e presenta situazioni e personaggi tratteggiati in maniera netta e priva di chiaroscuri: l’eroe positivo ha solo qualità positive e l’eroe negativo solo qualità negative. Il loro ingresso in scena è preceduto da precisi rulli di tamburo che li caratterizzano. Eroi ed anti eroi con le loro controparti femminili possono essere di tre livelli: superiore, medio, inferiore. I più elevati si esprimono in sanscrito mentre le donne e i personaggi di più basso lignaggio parlano in pracrito. La prosa si alterna alla poesia, la dizione al canto, il movimento alla danza e la musica è corollario indispensabile.
L’attore rappresenta il personaggio non tanto calandosi nella parte, quanto esprimendosi nel linguaggio convenzionale che è proprio del ruolo. Benché ogni innovazione sia esclusa, il bravo artista riesce ad essere originale pur nella rappresentazione dello stereotipo. Il livello sociale degli attori, inizialmente appartenenti alla casta sacerdotale, finì con lo scadere nel corso dei secoli, benché alcuni di loro fossero tenuti in alta considerazione.
L’opera teatrale si apre con il pūrvaranga, un insieme di preliminari rituali includenti una benedizione, che sono volti a trasformare il palcoscenico in un luogo sacro. Segue il prologo, dove vengono citati l’autore, la finalità dell’opera e gli eventi salienti. Quindi inizia l’azione scenica che si dipana in una serie di atti – da uno a quattordici, che possono a loro volta essere preceduti da prologhi –, i cui eventi si concludono nell’arco di un giorno. Il finale del dramma prevede sempre una preghiera di prosperità, che nuovamente ribadisce il carattere rituale della rappresentazione scenica.
Il dramma si propone di rappresentare un’azione, tratteggiare un personaggio, esprimerne i sentimenti. L’azione si sviluppa in una serie di “tempi”: l’inizio, il tentativo di conseguire l’obiettivo, la possibilità del conseguimento, la certezza di perseguirlo e il conseguimento finale. L’andamento degli eventi prevede: inizio, avanzamento, sviluppo, pausa, conclusione, mentre gli stili performativi possono essere verbale (nel senso di normalmente discorsivo), maestoso (adatto a particolari personaggi o situazioni di spicco), elegantemente aggraziato ed energico.
Il teatro sanscrito non si rivolgeva al popolo, ma all’èlite colta della società e presupponeva spettatori raffinati e preparati, capaci di cogliere elaborate sottigliezze espressive e linguistiche. A patrocinare le rappresentazioni erano i sovrani, i ricchi mercanti, i templi.
M.A.
NOTE
[1] L’aggettivo usato, benché non totalmente appropriato, indica il teatro di lingua sanscrita di cui abbiamo evidenze a partire dai primi secoli dell’era corrente.
[2] Brahmā, il dio che origina il mondo, è il primo aspetto della Trimūrti, la “Triplice forma” in cui si manifesta il Mistero Divino. Viṣṇu, signore della provvidenza, è la seconda. Śiva, la divinità che dissolve il mondo, è la terza.
[3] I termini “dramma” e “drammatico” sono qui da intendersi sempre come “svolgimento scenico” e non come genere con finale tragico. Il teatro indiano rifugge da rappresentazioni cruente in scena (eventuali avvenimenti tragici vengono solo narrati) e tanto meno da conclusioni negative.
[4] Il teatro, comunque, si basa su una finzione: l’attore finge di essere il personaggio che interpreta e lo spettatore finge di crederci. Le trasformazioni dell’attore che indossa più costumi e interpreta diversi ruoli vengono assimilate alle trasmigrazioni dell’ātman, l’anima, che riveste svariate forme nel suo peregrinare nella materia.
[5] Brahman in effetti significa “Assoluto”, ma in questo contesto è da intendersi come felicità, stupore, riposo nella propria essenza e nell’essenza del mondo.
[6] Dṛṣyakāvya.
[7] Rūpaka, che ha forma, rūpa.
[8] Le quattro caste sono citate per la prima volta nel Rigveda: brāhmaṇa, i depositari del sapere religioso, kṣatriya, i detentori del potere politico, vaiśya, la casta di sostentamento, śūdra, quella di servizio.
[9] Discepolo sotto la guida di un guru; capofamiglia; eremita; asceta itinerante.
[10] Il sūtradhāra, il nāyaka e il vidūṣaka sarebbero correlati a Brahmā, Indra e Varuṇa, protagonisti della prima mitica rappresentazione scenica, la vittoria degli dei sui demoni. Se per Brahmā, il demiurgo, e per Indra, l’eroico campione, l’assimilazione è facilmente comprensibile, non lo è altrettanto per Varuṇa, potentissimo dio celeste nell’epoca vedica, scaduto poi a dio dell’oceano in quella classica.
Pagine correlate
[menu_in_post_menu menu=58 style=”list”]