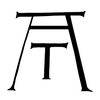Il Kathakaḷi – Poesia visibile
di Lucrezia Maniscotti
Introduzione
Il Kathakaḷi, che dal XVI secolo mantiene la sua forma originaria, è un “dance-drama”, un teatro che danza, una danza che racconta, un racconto di storie, in breve è uno spettacolo teatrale, in cui il testo cantato viene narrato dall’attore attraverso un vero alfabeto gestuale delle mani chiamato Mudrā e la mimica facciale, le storie perlopiù tratte dai grandi poemi epici indiani (Mahābhārata, Rāmāyaṇa, Purāṇa) che vengono contemporaneamente cantate dai musicisti in scena. La musica ha un ruolo fondamentale: sottolinea i passaggi drammatici, le emozioni, i movimenti scenici dei personaggi, per questo motivo il Kathakaḷi viene anche definito “arte totale”. Ma l’occidentale che incontra il Kathakaḷi è sicuramente colpito dai mastodontici costumi, dal trucco grottesco e dagli imponenti accessori come la corona di legno intagliata a mano e minuziosamente decorata, portata sulla testa dagli attori.
La prima volta che assistetti ad una dimostrazione di Kathakali, udii una parola del tutto nuova per me: Mahabharata. Un danzatore presentava una scena di quest’opera e la sua improvvisa apparizione da dietro un sipario ebbe su di me un impatto che non dimenticherò mai: indossava un costume rosso e oro, il viso era dipinto di rosso e verde, il naso sembrava una palla da biliardo bianca, le unghie erano affilate come coltelli, al posto della barba e dei baffi sporgevano due mezzelune bianche, le sopracciglia si alzavano e si abbassavano con la rapidità di bacchette sul tamburo, e le dita sibillavano strani messaggi in codice. Dalla magnifica ferocia dei movimenti, dedussi che si stava narrando una storia. …
La citazione è tratta da “il punto in movimento” di Peter Brook, che si è dedicato non tanto alla forma del teatro indiano, ma perlopiù ai contenuti, all’epica e al Mahābhārata in particolare, il più grande poema epico mai esistito e che Brook stesso avvicina a Shakespeare per la “densità umana” che li accomuna.
Insomma il trucco, il costume, la gestualità stilizzata, l’espressività codificata, i testi epici, i movimenti ampi e suggestivi, concorrono insieme a creare quell’immagine soprannaturale e fantastica dei personaggi del Kathakaḷi, un teatro dove dèi e demoni s’incarnano e salgono su un palco a recitarci le loro magiche storie.
Verso Oriente
L’Oriente ha sempre prodotto un certo fascino su tutte le arti e le scienze occidentali assumendo un ruolo fondamentale nello sviluppo della storia del teatro. I teatri dell’Asia sono stati inizialmente indicati come “teatri orientali”, termine che rimanda a un luogo non ben definito dell’altrove, ad un concetto di esotismo che si è sviluppato nei secoli e che nel Novecento si specifica con la formula di “teatri asiatici”.[1] Negli ultimi decenni, l’artista italiano Eugenio Barba, ha proposto la definizione di “teatro eurasiano” utilizzando un termine geografico che sottolinea la continuità della massa continentale tra Europa e Asia, per indicare un terreno comune tra le diverse tradizioni teatrali a partire da un’identità collettiva professionale che “comporta il superamento dell’etnocentrismo fino a scoprire il proprio centro nella «tradizione delle tradizioni»” [2].
La storia del teatro occidentale ha dovuto fare i conti con le tradizioni asiatiche a partire dagli anni a cavallo tra il XIX e il XX secolo, quando in Europa gli artisti cominciarono a ribellarsi alle forme del teatro naturalistico ottocentesco, quando si sperimentavano altre tipologie di messa in scena (teatro simbolista, futurista, ecc), quando nasceva il teatro di regia, l’evento rivoluzionario della storia del teatro del Novecento.
Inizialmente l’interesse verso l’Oriente era perlopiù focalizzato sulla drammaturgia (il testo del teatro classico sanscrito “Śakuntalā” aveva già affascinato il poeta Göethe), ma grazie ai tanti esperimenti di importanti teatranti occidentali l’attenzione si spostò verso la messinscena vera e propria.
Non potendo dilungarci nei particolari, ci limitiamo a citare alcuni dei personaggi più significativi: Gordon Craig è tra i primi che si occupano di cercare dei principi universali che governano tutte le tradizioni sia asiatiche che europee, e proprio studiando la teoria dell’origine del teatro indiano dalle marionette, pare che Craig abbia preso lo spunto per scrivere il suo testo più conosciuto “L’attore e la supermarionetta” da cui deriva la teoria dell’attore che deve superare la realtà diventando una supermarionetta.
Il teatro giapponese negli stili Nō e Kabuki ha influenzato artisti come Copeau, Claudel, Mejerchol’d, cambiando la loro vita artistica e dando vita all’importante riflessione sul divario convenzione/libertà tra il teatro orientale e quello occidentale, che accomuna tutti i teatranti che hanno incontrato l’oriente sul loro cammino.
Bertold Brecht invece rimase incantato dall’interprete cinese dell’Opera di Pechino, Mei Lanfang, tanto che volle incontrarlo e divenne l’argomento principale delle sue riflessioni teatrali. Nacquero così le importanti teorie di Brecht che, ancora oggi, fanno discutere teorici e artisti; ci riferiamo in particolare all’ “effetto di straniamento” che l’attore deve utilizzare sulla scena per concorrere a creare ciò che sarà poi per Brecht il “Teatro Epico”.[3]
Possiamo affermare che dalla seconda metà del XX secolo, in campo teatrale, l’Oriente non è più solo un luogo mitico, sconosciuto, e a volte solo immaginato, ma diventa un esempio reale (attori e danzatori asiatici sono regolarmente in tournèe in Europa e negli USA), un confronto continuo sulle pratiche, il training e la messa in scena vera e propria.
Per quanto riguarda l’India, Jerzy Grotowski dapprima si interessa alla cultura indiana in generale, poi mette in scena il testo “Śakuntalā” di Kālidāsa e infine viaggia nel Subcontinente, prendendo spunto dalla tradizione teatrale indiana per l’elaborazione delle sue teorie sulla “partitura d’azione” e sul training fisico che segneranno il lavoro del suo gruppo, il Teatro Laboratorio:
Il mitico protettore dell’antico teatro indiano era Shiva, il danzatore Cosmico, che danzando «fa nascere» tutto e tutto «distrugge»; e che «danza il tutto». […] Se dovessi definire la nostra ricerca teatrale in una frase, con una parola, mi riferirei al mito della danza di Shiva.
Direi: «Stiamo giocando a fare Shiva. Stiamo recitando Shiva». […] E’ la danza della forma, la pulsazione della forma, la fluida diffusione della molteplicità, di convenzioni teatrali, stili, tradizioni di recitare. È la costruzione degli opposti: gioco intellettuale nella spontaneità, serio nel grottesco, derisorio nella sofferenza. Questa è la danza della forma che distrugge tutte le illusioni teatrali, ogni «verosimiglianza con la vita».[…] L’antico teatro indiano, gli antichi teatri giapponese e greco, non erano una «presentazione» della realtà (che è una costruzione di illusioni) ma piuttosto una danza della realtà (una falsa costruzione talvolta sull’ordine di una «ritmica visione» che si riferisce alla realtà…) […] Ecco una citazione mitologica: «Shiva dice… io sono senza nome, senza forma, senza azione… io sono pulsazione, movimento, ritmo» (Shiva-Gita). L’essenza del teatro al quale aspiriamo è pulsazione, movimento, ritmo.[4]
Nel 1963 Eugenio Barba viaggia in India, in Kerala, si dirige precisamente nel piccolo paese di Cheruthuruthi dove ha sede l’accademia “Kerala Kalamandalam”, incontra così il teatro Kathakaḷi, ne studia attentamente l’allenamento e, una volta tornato in Europa, porta alcuni esercizi di questa pratica al Teatro Laboratorio di Grotowski di cui è assistente. Questa nuova disciplina resterà una base fondamentale del lavoro di Barba con il gruppo che poi fonda nel 1964, a Oslo: l’Odin Teatret. Secondo Barba l’attore orientale partendo da una griglia di convenzioni e azioni prestabilite e codificate, può creare con maggiore libertà, rispetto all’attore occidentale che non possedendo regole, obblighi a cui riferirsi, si perde nella ricerca di una forma, convinto che basti il testo e la regia ad aiutarlo nella sua creazione artistica.
All’Odin Teatret si studiano i principi comuni delle diverse tradizioni teatrali, nasce l’“antropologia teatrale”, un nuova disciplina che sfocia, nel 1980, nella fondazione dell’ISTA (International School of Theatre Anthropology): un laboratorio di ricerca interdisciplinare dove Barba e i suoi collaboratori propongono una via alternativa di formazione, che prevede lo studio regolare con Maestri orientali (dall’India, dal Giappone, da Bali e dalla Cina). Non vengono formati quindi artisti di discipline orientali, ma queste vengono utilizzate per la formazione di attori occidentali, duttili e creativi, che usano tecniche precise (l’uso del corpo in maniera extraquotidiana, la danza, la scoperta di tutte le possibilità della voce, ecc) atte a formare un teatro che sia comunicativo e universale grazie al principio della “pre-espressività” coniato da Barba.[5]
Nel teatro occidentale si è sempre alla ricerca di uno stile, di una forma che si adatti al contenuto, mentre l’oriente ha mostrato un’altra strada: partire dalla forma codificata, stilizzata, per attraversare il corpo, dimenticandosene, e arrivare al cuore, al sentimento, al contenuto.
Per prendere questa seconda strada, però, bisognava innanzitutto colmare quella frattura che si era creata tra teatro e danza dai tempi della commedia dell’arte in poi, ovvero da quando il teatro è diventato soprattutto “parola”. È anche per questa ragione, per recuperare quella importante dicotomia tra teatro e danza, che molti teatranti, registi, attori, hanno cominciato a interessarsi del teatro orientale, tanto che alcuni studiosi (Nicola Savarese) hanno coniato il termine “teatro eurasiano”.
Questo importante momento di contatto e scambio con la cultura asiatica, è diventata un passaggio obbligatorio, almeno di conoscenza, per i teatranti occidentali; alcuni dei quali hanno scelto di dedicarsi interamente e seriamente a queste discipline (in Italia l’esempio forse più importante è il Teatro Tascabile di Bergamo che da 25 anni si occupa di formare attori-danzatori di Kathakaḷi e di altre arti sceniche indiane), altri invece, come Ariane Mnouchkine a Parigi, hanno scelto di utilizzare a volte le forme, le tecniche del teatro asiatico applicandole ai testi della tradizione occidentale, a volte sono stati catturati dai contenuti, dalle mitologie, dai rituali, dall’universalità dei messaggi e della comunicazione, come nel caso di Peter Brook.

Kathakaḷi: a ritmo di racconti
Non esiste un termine corretto per definire il Kathakaḷi, letteralmente “racconto di storie”; nel corso degli anni è stato chiamato mimo, pantomima, teatro-danza, teatro, opera, ecc. Il premio Nobel indiano Rabindranath Tagore negli anni cinquanta lo definì “teatro totale”, mentre lo studioso Nicola Savarese ha coniato la definizione di “arte del teatro che danza”[6] riferendosi a tutte le forme di arti sceniche di stampo teatrale indiane.
Effettivamente il Kathakaḷi presenta tutti gli ingredienti di uno spettacolo teatrale: è un evento che accade nel momento in cui degli attori raccontano a degli spettatori una storia scritta (o meglio riscritta su racconti preesistenti) da un autore appositamente per il teatro. Presenta però delle caratteristiche molto particolari: il racconto verbale è affidato al canto e contemporaneamente gli attori mimano le frasi scandite dai cantanti; queste parti per così dire recitate sono intervallate da brani di danza cosiddetta pura.
Possiamo quindi affermare che il Kathakaḷi comprende tutte le tipologie di spettacolo sopra citate (noi per semplicità utilizziamo il termine teatro-danza), ma le sue caratteristiche sono così uniche da non poter essere collocato in una qualsiasi altra categoria che non sia se stesso.
Le origini
“God’s own country” la patria di Dio, così è soprannominato il ricco stato del Kerala, rinomato per i suoi magnifici paesaggi: monti, palme, fiumi, ma anche per le molte forme di spettacolo che vi si sono sviluppate.
Il Kathakaḷi nasce proprio nel lussureggiante Kerala del XVII secolo dalla confluenza delle tradizioni artistiche keralesi di stampo sia classico sia folkloristico e sia rituale.
Per quanto riguarda l’influenza classica si è già accennato, nel capitolo precedente, al teatro sanscrito Kūṭiyāṭṭam, letteralmente “azioni combinate”.
Questo tipo di teatro nato intorno al X secolo, è in completa aderenza con le norme dettate dal Nāṭya Śāstra, prevede uno studio approfondito della lingua sanscrita (solo alcuni personaggi come il vidūṣaka, il clown della tradizione teatrale classica, e le donne utilizzano il prakrito, la lingua del popolo) ed è, almeno in origine, un “temple-drama”.
Il Kathakaḷi ha utilizzato gli elementi base del teatro Kūṭiyāṭṭam quali l’uso delle mudrā, la teoria del rasa,[7] parte del trucco e costumi e il legame stretto con il tradizionale patronato delle classi alte (nello specifico i Nambudiry).
Un’altra fonte importante per la nascita del Kathakaḷi è l’antica pratica marziale di origine dravidica [8] chiamata Kalaripayattu, termine composto da kalari che significa “arena, campo di battaglia, spazio per fare esercizi”, e payattu “praticare, esercitarsi”. Questa disciplina fiorisce e prende la forma attuale all’interno del sistema medievale keralase del XII secolo ed era appannaggio della casta dei Nayar, inizialmente protettori dei Brāhmaṇi, in seguito a servizio dei governatori dei vari distretti (rāja), diventando col tempo i responsabili del training militare nelle truppe di difesa.
Il Kathakaḷi, come tante altre discipline indiane, ha ereditato molto da questa pratica. Innanzitutto per ciò che concerne la concentrazione e la preparazione degli attori-danzatori, sottoposti nelle prime ore del mattino ad un massaggio completo di tutto il corpo (usando oli medicinali āyurvedici) particolarmente doloroso anche se pare molto efficace nella preparazione della muscolatura e delle articolazioni; ma soprattutto il Kathakaḷi si rifà a movimenti, segmenti ritmici e modelli coreografici chiaramente derivati dal Kalaripayattu, in particolare il Kathakaḷi utilizza le tecniche di combattimento proprie dei Kalari (chi pratica il Kalaripayattu), nella rappresentazione di battaglie o nelle scene in cui si racconta la preparazione delle armi, ma anche in alcune unità di danza pura come le Kalāśsamdi cui parleremo più approfonditamente nei paragrafi successivi.
Nel campo ritualistico il Kathakaḷi trae origine dalle rappresentazioni sacre del Teyyam e del Mutiyettu.
In Kerala durante il festival annuale in onore della dea Kālī, i fedeli dopo la preghiera si dedicano alla creazione del Kalam, un disegno di buon auspicio in cui è rappresentata la dea nella forma di Bhādrakālī. Al termine delle cerimonie ritualistiche intorno al disegno inizia la messa in scena della storia mitica della dea, dalla sua nascita (creata dal terzo occhio del dio Śiva), all’uccisione, scopo della sua creazione, del demone Dārika. Questa rappresentazione rituale prende il nome di Mutiyettu e ha in comune con la danza Teyyam il trucco, i costumi, la musica, i colori (il rosso per esempio è molto utilizzato per indicare sangue, energia femminile), il canto in stile tōṭams (primissima forma di letteratura Malayālam),[9] ma differiscono poiché il Teyyam è un rito propiziatorio che prevede circa trecento diverse forme di spettacolo rituale, mentre il Mutiyettu ha solo questa forma sopra descritta di rito.
Il Teyyam letteralmente significa dio e per estensione “danza degli dei”, la sua origine trae fondamento dagli antichi rituali propiziatori tipici dei villaggi. Principalmente danzato, il racconto delle storie divine è affidato al canto, ma il momento più suggestivo è sicuramente la fase del trucco: chiunque abbia assistito ad uno spettacolo di Teyyam sostiene di aver visto la trasformazione del danzatore in un essere divino, soprannaturale. La cerimonia prevede diversi momenti, tra cui la raccolta delle offerte dei devoti con la relativa prasāda (in tutta l’India si usa ricevere fiori o cibo benedetto, dopo che si è fatta un’offerta a una divinità), la proclamazione di profezie ed oracoli, e naturalmente la performance danzata e suonata dal vivo, il tutto illuminato da lampade e torce che vengono utilizzate anche dai danzatori per suggestivi movimenti che prevedono l’uso del fuoco.
It (Teyyam) is a Drishyakavya or visual poetry destined to create rasa or emotive experience. It is a great theatre of the people.[10]
Eppure il Teyyam, nonostante tutti i riconoscimenti e il debito che ha il teatro indiano del sud India, Kathakaḷi compreso, nei suoi confronti, non è riuscito a svilupparsi come arte classica, soprattutto a causa della cornice ritualistica in cui è ancora immerso.[11]
Il Kathakaḷi di queste forme rituali di teatro ha mantenuto alcuni aspetti formali come la musica, la danza, il trucco, in breve quell’immagine soprannaturale di questo teatro, ma anche aspetti contenutistici di notevole importanza, come l’eterno conflitto bene/male e quindi dèi/demoni, ma anche l’essenza sacra, il rito di mettere in scena storie divine.
Per quanto riguarda l’aspetto folkloristico torniamo all’influenza che ebbe sulle opere keralesi il poema vaiṣṇava scritto da Jayadeva, il Gītagovinda.
Si narra che Manaveda, il governatore del Kozhikode nella zona nord del Kerala, scrisse intorno al 1650 ispirandosi alla ormai popolare opera di Jayadeva, la Kṛṣṇāgīti: un ciclo di otto “dance-drama” basati sulle vicende della vita di Kṛṣṇā.
Nasce così il genere Kṛṣṇāṭṭam, tradizionalmente rappresentato nel famoso tempio di Guruvayur come offerta dei devoti al dio Kṛṣṇā.
Il Kṛṣṇāṭṭam è un dramma in lingua sanscrita danzato e raccontato in terza persona attraverso il canto. Zarrilli lo definisce “la madre del Kathakaḷi” e insieme al Kūṭiyāṭṭam e al Kalaripayattu costituisce il contributo più significativo per la nascita del Kathakaḷi.
Nascita e sviluppo
Si racconta che nella seconda metà del 1600 Kottarakara Thampuran, principe di un distretto del sud del Kerala, chiese a Manaveda di inviargli la troupe del Kṛṣṇāṭṭam per una festa di matrimonio. Il governatore del Kozhikode, non solo rifiutò, ma pare anche che aggiunse una nota insultante sull’incapacità degli abitanti del sud del Kerala di apprezzare il Kṛṣṇāṭṭam.
Kottarakara Thampuran, offeso, decise di rispondere alla provocazione inventando lui stesso un altro genere di spettacolo, nasce così il Rāmanāṭṭam, un ciclo di otto opere sulla storia del dio Rāma, formalmente molto simile al Kṛṣṇāṭṭam, in realtà di grande innovazione soprattutto per l’inserimento della lingua Malayālam, che permise la rapida diffusione del nuovo genere. Il Rāmanāṭṭam presto si estese in tutto il Kerala fino a quando un altro principe, Kottayam Tampuran (1645-1716) Rāja del nord del Malabar, scrisse quattro opere basate sui racconti del Mahābhārata: nasce così il Kathakaḷi, grazie, ancora una volta, alla funzione importantissima dei patroni unita a quello spirito di raffinatezza, ricercatezza che contraddistingue le arti indiane:
L’indiano ha esplorato senza sosta tutte le possibilità dell’esperienza umana qualunque aspetto essa abbia: si tratti del più umile e più sorprendente degli strumenti umani, il dito, tutto quello che esso può fare è stato esplorato e codificato; si tratti di una parola, un respiro, un arto, un suono, una nota o una pietra, un colore, una stoffa, tutti gli aspetti, pratici, artistici e spirituali, sono stati esaminati e collegati. L’arte consiste nel celebrare le più raffinate possibilità di ogni elemento, nell’estrarre l’essenza da ogni dettaglio così che questo possa rivelare se stesso come parte significativa di un tutto indivisibile.[13]
Il Kathakaḷi è subito apprezzato in tutto il Kerala, soprattutto per alcune sue caratteristiche che avvicinano il teatro alla gente: è la prima arte che esce dalle mura del tempio, viene infatti rappresentato negli spiazzi fuori dai luoghi sacri o nelle corti dei rāja, oppure nelle case dei privati, veri e propri patroni e mecenati.
Il Kathakaḷi presenta importanti innovazioni che concorrono alla sua rapida diffusione, tra le quali si devono segnalare le novità linguistiche e canore. Nasce con il Kathakaḷi la letteratura āṭṭakatha, uno stile che utilizza il linguaggio comunemente definito “malayālam sanscritizzato” che unisce la lingua letteraria delle corti keralesi, detta manipravalam, con lo stile di canto tōṭam, più comprensibile dalla maggior parte della popolazione.
Un’altra novità fondamentale del Kathakaḷi era l’introduzione dei cantanti: precedentemente erano gli attori che oltre a mimare e a danzare avevano anche il compito di dover cantare i racconti. Con l’introduzione dei cantanti gli attori-danzatori ebbero la possibilità di una maggior libertà di movimento e di conseguenza una più precisa attenzione al loro lavoro mimico danzato.
Grazie al successo e alla sua rapida diffusione, al Kathakaḷi è permesso uno sviluppo e un processo di raffinatezza mai conosciuto nelle altri arti. L’apice viene raggiunto intorno al 1850 quando il Kathakaḷi prende la forma che ancor oggi conosciamo.
Invece, negli ultimi anni del XIX secolo i cambiamenti socio-economici dettati soprattutto dalle politiche coloniali degli inglesi minacciano di far scomparire quest’arte. I patroni infatti, sostenitori del Kathakaḷi fin dalla nascita, non sono più in grado di provvedere al supporto e promozione del teatro, lasciando che molte compagnie, non più in grado di sopravvivere, scompaiano.
Si rende conto della grave situazione in cui versa il Kathakaḷi il poeta keralese Vallathol Narayana Menon, che decide di tentare di salvare la tradizione teatrale organizzando negli anni Venti, una struttura per il supporto del Kathakaḷi: nasce il KERALA KALAMANDALAM; dapprima è una compagnia d’artisti rigorosamente scelti e guidati da Menon, che si procurano da vivere con tournée in giro per l’India, poi grazie anche alla fama che acquistano come compagnia organizzano una scuola, l’accademia nazionale oggi conosciuta in tutto il mondo. Il Kerala Kalamadalam viene con gli anni riconosciuto ufficialmente dapprima dal governo di Cochin, poi da quello del Kerala diventando un’istituzione amministrata dallo stato (con supporti economici fondamentali ma con immaginabili intrusioni nel lavoro artistico).
Il Kathakaḷi dunque si salva per intuizione di un appassionato conoscitore dell’antica arte e l’accademia Kalamandalam diventa un modello da imitare per le varie scuole che nascono nel corso del XX secolo, tra le quali segnaliamo la MARGI che ha sede nella capitale del Kerala, Trivandrum, rappresentante dello stile Kathakaḷi chiamato “del sud”, per distinguirlo da quello del Kalamadalam considerato del nord.[14]
Dal training alla messa in scena
Il percorso per diventare attori-danzatori di Kathakaḷi è piuttosto lungo e faticoso, ci sono diverse strade possibili per studiare questo tipo di teatro, la più comune è quella di seguire un ciclo di studi presso una scuola, pubblica o privata. Il Kerala Kalamandalam – State Academy of Arts, nasce a Cheruthuruthi, un piccolo paese della provincia di Trichur all’incirca nel centro dello stato del Kerala, e seleziona i ragazzi (il Kathakaḷi è un’arte tradizionalmente maschile e anche se negli ultimi anni molte ragazze hanno cominciato a studiarlo, non sono ancora accetate nelle accademie) dai 13 anni, ma in India esiste ancora la pratica chiamata gurukkula: l’apprendimento diretto maestro-allievo che può cominciare appena si è in grado di camminare e poi, se si vuole, si continua a studiare in un’accademia.
Una volta entrati nella scuola il lavoro è molto duro. Il ciclo di studi sia per gli attori-danzatori che per i musicisti o cantanti che per i truccatori costumisti è di sei anni di frequenza obbligatoria con solo due mesi di vacanza l’anno. Per gli allievi attori-danzatori vanno poi aggiunti due anni di specializzazione. Tranne pochi studenti fortunati che hanno la famiglia che abita o che va ad abitare nelle vicinanze di Cheruthuruthi, la maggior parte degli studenti vive all’interno del campus della scuola in apposite strutture in continuo contatto con i compagni di studi.
Per affrontare un clima caldo come quello del sud India, le lezioni iniziano molto presto: normalmente alle quattro del mattino quando ancora non è sorto il sole; si comincia con gli esercizi per gli occhi, poi si passa al massaggio a cui si è accennato nel precedente paragrafo, per finalmente arrivare alla colazione. La mattinata è dedicata all’allenamento fisico quindi alla memorizzazione e ripetizione di sequenze di danza e di racconto mimico di brani estrapolati dal repertorio: durante gli anni di studio, vengono insegnate ai ragazzi alcune opere selezionate, in ordine di difficoltà interpretativa, che fanno parte del repertorio scelto della scuola. Questi insegnamenti resteranno impressi negli studenti affinché, una volta terminati gli studi, i ragazzi siano in grado di eseguire un qualsiasi brano del loro repertorio con una qualsiasi compagnia e senza nemmeno fare una prova (situazione inconcepibile nel teatro occidentale).
Nel primo pomeriggio si fanno solo lezioni teoriche, normalmente si studiano le materie considerate importanti per una più approfondita conoscenza del teatro-danza Kathakaḷi: la letteratura malayāli, la lingua sanscrita, l’epica indiana e la musica carnatica (stile classico del Sud India).
Durante il ciclo di studi, ogni studente impara ad eseguire tutti i personaggi, però viene di solito instradato dai suoi insegnanti verso l’analisi minuziosa di un ruolo preciso (ruoli femminili, eroici, buffi, furiosi, ecc) così al termine della scuola (solitamente gli attori-danzatori frequentano anche i due anni in più di specializzazione in cui possono imparare alcuni capolavori del Kathakaḷi), gli studenti possono essere chiamati da organizzatori o più esperti artisti per piccoli ruoli che si confanno alle loro caratteristiche.
Negli ultimi tempi il Kathakaḷi, come tutte le arti classiche (indiane e non solo), ha dovuto fare i conti con la concorrenza dei mezzi di comunicazione di massa, con le moderne arti visive (cinema in particolare), e con le nuove esigenze che la vita moderna comporta. Ciò ha portato ad una riduzione dell’interesse verso il Kathakaḷi non solo da parte degli spettatori, ma anche degli stessi giovani artisti, che una volta frequentata la scuola, spesso non intraprendono l’attività artistica per dedicarsi o a studi universitari di tutt’altro tipo o a lavori meno interessanti, ma molto più redditizi o perlomeno sicuri.
Per i pochi che intraprendono l’attività artistica, la strada è piuttosto tortuosa. A un giovane attore spettano molti anni di gavetta e un graduale passaggio dai ruoli minori a quelli più importanti, cambiamento che può avvenire solo grazie al consenso e al grado di apprezzamento del pubblico. Alcuni riescono ad assicurarsi un piccolo salario con l’insegnamento, o nella stessa scuola dove hanno studiato, oppure aprendo scuole private o dando lezioni individuali. Alcuni invece diventano delle vere e proprie star osannate ovunque, è il caso di un artista molto conosciuto e apprezzato, Kalamandalam Gopi, di cui si sente parlare molto non solo in Kerala o in India, ma in tutto il mondo; basti pensare che quasi tutte le copertine dei libri di Kathakaḷi presentano una foto di questo artista che ha qualità non comuni e una forza espressiva dirompente.
L’abhinaya
Per entrare nello specifico della pratica del Kathakaḷi, dobbiamo ancora una volta riferirci al Nāṭya Śāstra, laddove l’antico testo ci parla dell’abhinaya: l’arte della recitazione, dell’espressività e quindi la capacità di arrivare al pubblico.[15] Il trattato sostiene che ci sono quattro tipi, quattro ramificazioni dell’abhinaya che concorrono insieme al fine di raccontare e di produrre certe emozioni nello spettatore. La prima si chiama Āṅgika che possiamo tradurre con espressività corporea, la seconda Vācika, la comunicazione verbale e musicale, la terza ramificazione, ĀhāryaSāttvika è la caratteristica più complessa da descrivere poiché comprende l’interiorità dell’attore, è infatti l’espressione dell’emozione del personaggio.[16]
Nei paragrafi successivi, abbiamo cercato di descrivere meglio il Kathakaḷi seguendo nell’ordine questa classificazione dei vari tipi di abhinaya.
La danza e la gestualità
Āṅgika è l’espressione drammatica o la rappresentazione attraverso la gestualità, la mimica facciale, il corpo.
Il termine “corpo” indica il movimento fisico dell’attore, comprende dunque tutte le sequenze di danza, i segmenti di movimento e le posture fisiche. La danza può essere di vari tipi, ci sono coreografie di cosiddetta “danza pura” in cui non viene raccontata alcuna storia, come le composizioni kalāśam che servono da legame o per accentuare il sentimento drammatico, oppure le danze preliminari, puṛrappātu e tōṭayam, sequenze di sola tecnica, che vengono eseguite da giovani artisti all’inizio degli spettacoli. Ci sono poi delle coreografie più espressive che sono inserite in un preciso contesto drammatico: questo tipo di danze possono raccontare battaglie o introdurre un personaggio, la “sāri dance” ad esempio, viene eseguita come entrata in scena di un’eroina femminile, sottolineando l’aspetto erotico e pieno di grazia.
Anche la mimica facciale richiede un allenamento quotidiano nel periodo dell’apprendimento e una continua attenzione per ogni attore già formato, se non altro perché proprio al volto è affidata l’espressività degli otto rasa, i sentimenti codificati dalla tradizione indiana già dai tempi del Nāṭya Śāstra: śṛṅgāra (amore), hāsya (comico), karuṇa (compassione), raudra (furia), vīra (eroismo), bhayānaka (paura), bībhatsa (disgusto), adbhuta (meraviglia), a cui si è aggiunto solo successivamente un nono rasa, śānta (pace). I maestri di Kathakaḷi insegnano una serie di micro movimenti facciali (guance, sopracciglia, bocca, occhi, ciglia) e mostrano le combinazioni base per raggiungere l’espressione del viso codificata per ciascuno dei nava rasa.
La gestualità invece è affidata a quell’alfabeto vero e proprio che costituisce il linguaggio delle mudrā, un codice molto preciso usato al posto delle parole, che può essere suddiviso in tre grandi categorie: i gesti ad una sola mano (asaṃyukta), quelli con due mani (saṃyukta) e quelli misti (miśra). Ogni mudrā può avere diversi significati, a seconda del contesto e dal personaggio; alcuni gesti sono puramente ornamentali, come quelli che vengono utilizzati nelle coreografie di danza pura, mentre altri possono indicare un nome proprio, una divinità, descrivere un paesaggio, un sentimento, fino a dialogare con gli altri personaggi in scena, senza emettere parole, [17] il racconto verbale infatti è affidato al canto.
La musica e i testi
Vācika deriva da vāc che significa voce, parola, linguaggio, frase, il vācikābhinaya comprende quindi tutto ciò che riguarda la musica e il testo.
In classe lo studio del repertorio di Kathakaḷi è chiamato colliāṭṭam che letteralmente significa recitare e danzare poiché, come già accennato nei paragrafi precedenti, in origine l’attore-danzatore recitava il testo mentre danzava.
Oggi invece le parole sono affidate al canto del ponnani, il primo cantante che svolge la funzione di direttore d’orchestra. Il ponnani, oltre a svolgere il compito di cantare per primo ogni verso del brano, è il punto di riferimento sia ritmico (suona un piccolo gong) che melodico di tutti i musicisti. L’orchestra Kathakaḷi prevede inoltre un secondo cantante che suona i cembali (iḷattāḷam) e tre percussionisti con i diversi strumenti: il maddaḷam che essendoperennemente in scena, sostiene tutta la ritmica, il ceṇṭa che sottolinea ogni dettaglio del racconto e della danza e che scompare quando ci sono personaggi femminili che a loro volta vengono invece sostenuti dal iṭakka. Ci sono diverse strutture ritmiche che costituiscono il tāla, il tempo, che può essere in tre velocità, lenta, media o veloce, a seconda del momento scenico.
Il canto originariamente era nell’antico stile “Sōpāna rīti”, derivato dai canti devozionali del Gītagovinda, ma col passare del tempo la musica classica carnatica e l’utilizzo dei microfoni, hanno mutato completamente lo stile di canto originario. È rimasto invariato il ruolo dei cantanti, che devono introdurre il rāga, la melodia, creando l’ambiente emotivo di sostegno alla scena e dando naturalmente voce ai personaggi.
I testi del repertorio tradizionale Kathakaḷi (āṭṭakatha), venivano scritti dai membri delle alte classi sociali ed erano tratti dalla grande epica indiana: la maggior parte racconta scene tratte da Mahābhārata, Rāmāya±a, Bhāgavata Purāṇa o altri testi tradizionali. Delle centinaia di opere scritte nel corso dei secoli, oggi vengono prevalentemente messe in scena circa quaranta o cinquanta testi.
La struttura drammaturgica prevede l’alternanza di śloka e pada. Gli ślokasono sezioni narrative scritte in sanscrito e in terza persona, sono parti solo cantate, senza accompagnamento delle percussioni e spesso senza nemmeno gli attori sul palco, svolgendo quindi la funzione di narratore. I pada invece sono scritti in prima persona in malayālam sanscritizzato e sono accompagnati dagli altri strumenti, poiché costituiscono le sezioni di dialogo o di soliloqui interpretate dagli attori sul palco. Ogni verso di ciascun pada viene normalmente ripetuto due volte, per dare la possibilità al danzatore di raccontare dapprima il sentimento generale, l’essenza, il sottotesto che sta dietro a quelle parole, e poi di mostrare il significato letterale della frase cantata.
Esistono poi le interpolazioni, iḷakayaṭṭam, delle specie di improvvisazioni non cantate, bensì raccontate dall’attore attraverso la gestualità, che però si rifanno a un testo scritto in precedenza, appositamente per quell’attore, da un esperto di Kathakaḷi. Non è un’improvvisazione come s’intende in occidente, ma piuttosto un canovaccio molto fitto e in parte quasi tutto stabilito, s’improvvisa infatti più sul sentimento che non sul racconto. Le iḷakayaṭṭam possono essere di vario tipo: brevi soliloqui che fungono da raccordo tra due scene, il personaggio in questo caso può raccontare cosa sta facendo o può esprimere i suoi pensieri; oppure possono essere momenti descrittivi della situazione in cui si è trovato il personaggio, ad esempio può descrivere la foresta; o ancora può essere di tipo melodrammatico, in cui un personaggio può descrivere il suo travaglio interiore alle prese con una decisione importante o in una situazione particolarmente difficile.
Il trucco e i costumi
Il termine āhārya indica tutto ciò che concerne la parte più esteriore e più visibile del Kathakaḷi: il trucco e il costume.
Vicino al palcoscenico dove avviene lo spettacolo, esiste una sala deputata al trucco e alla vestizione, un camerino chiamato all’inglese greenroom. Entrare in questo spazio prima di una rappresentazione è come varcare la soglia d’accesso a un altro mondo: in silenzio, i truccatori si aggirano preparando paste per il make-up, gli attori invece stanno sdraiati o seduti su stuoie a farsi truccare, appesi lungo le pareti ci sono gli enormi costumi, mentre a terra sono ordinatamente posati oggetti e gioielli di scena; di solito il greenroom è illuminato solo dalle lampade a olio che concorrono a creare suggestione e aiutano la concentrazione degli attori.
Durante questa fase laboriosa si assiste all’importante momento della trasformazione dell’attore nel personaggio, attraverso un trucco che cambia completamente i connotati tanto da sembrare una maschera, e un costume stilizzato e allo stesso tempo enorme (il peso complessivo può raggiungere i trenta Kilogrammi) che, grazie anche a ornamenti come corone, bracciali, collane, unghie finte, concorre a creare l’immagine di esseri semidivini, soprannaturali.
I personaggi del Kathakaḷi si possono racchiudere in tre categorie principali che rappresentano i tre mondi: l’universo celeste degli dèi, il regno di mezzo degli uomini e il mondo malvagio dei demoni.
Ci sono sei principali tipologie di personaggio che prevedono lo stesso trucco, lo stesso costume e che hanno delle caratteristiche identiche, ma che si comportano in modo completamente diverso a seconda della storia e della circostanza in cui sono inseriti. Il tipo più diffuso è il pacca (con il volto verde) che è l’eroe, il personaggio virtuoso; il katti invece è l’arrogante di nobile origine, mentre del tipo tāṭi , caratterizzato dalla barba, si hanno tre ramificazioni che cambiano del tutto il senso del personaggio: quelli con la barba rossa o nera sono malvagi, vili e spesso ridicoli, mentre il personaggio con la barba bianca è un essere superiore, divino. Ci sono poi le kari, grottesche demonesse chiaramente legate alla foresta, dipinte perlopiù di nero e con ridicoli seni finti; spesso le kari per sedurre gli uomini si trasformano nel tipo minukku (radiante), ovvero nella donna classica, questo personaggio è il meno agghindato, prevede infatti un volto tendente al giallo con un trucco più “semplice” (è comunque una stilizzazione dell’aspetto femminile visto che tradizionalmente gli attori sono sempre uomini) e con un vestito che ricorda il tipico sari keralese. In realtà minukku può essere anche un personaggio maschile, è il caso dei bramini, saggi o messaggeri. L’ultimo tipo è il tēppu, che comprende una serie di personaggi speciali che non rientrano nelle altre categorie.
Il trucco è costituito da materie vegetali, pietre minerali polverizzate, sapientemente miscelate; caratteristico di alcuni personaggi è il cuṭṭi, sporgenze di pasta di riso che prolungano certi lineamenti del volto, cambiandone l’aspetto originario. Alcune (il minukku per esempio ne è privo) tipologie di personaggio ha poi una diversa corona, chiamata kiratam, fatta di legno e tutta decorata e intagliata minuziosamente con fogli sottili color oro o altri materiali naturali come le piume dei pavoni.
Il costume è perlopiù composto da un pantalone bianco sovrastato da un’ampia gonna sorretta da metri di stoffa inamidata e arricciata, mentre il busto è coperto da una blusa, generalmente di cotone, allacciata sul retro; tutto il costume è poi agghindato da decorazioni di vario tipo, tutte appositamente costruite a mano solitamente in legno come la corona: bracciali, collane, cavigliere, ecc… Obbligatorio è inoltre portare dei lunghi capelli posticci allacciati intorno al collo.
Prima di entrare in scena l’attore si inserisce un seme (indolore) negli occhi che li fa diventare rossi, anche questo espediente concorre a creare quell’immagine soprannaturale e fantastica dei personaggi del Kathakaḷi, un teatro dove dèi e demoni s’incarnano e danzano per raccontare storie epiche e mitiche.
L’espressività interiore
Nel processo di apprendimento del Kathakaḷi, gli insegnanti si preoccupano innanzitutto di insegnare la forma, il corpo, i gesti, i racconti, consapevoli che il Sāttvika, l’espressività interiore, si sviluppa nell’esperienza sia umana che di palco, nella conoscenza delle emozioni profonde di ogni attore e di ciascun personaggio.
Saper esprimere le emozioni è fondamentale nel teatro indiano poiché il fine di questa (e di tutte le altre arti tradizionali indiane) è di far raggiungere allo spettatore il rasa, l’esperienza estetica. Il teatro indiano però non cerca di creare un’illusione di realtà, bensì prova a raccontare emozioni, miti, situazioni, attraverso una forma estremamente codificata, ma che diventa credibile nel momento in cui l’attore è capace, all’interno di questa cornice formale, di esprimere il sentimento, lo stato d’essere (bhāva) generale dell’opera che rappresenta e le varie emozioni transitorie che il personaggio prova nelle diverse situazioni del dramma.
Il percorso di un interprete Kathakaḷi prevede quindi il raffinarsi dell’arte quanto più maturo è l’attore, ci sono infatti alcuni personaggi che normalmente vengono interpretati solo da artisti che hanno almeno quarant’anni (ad esempio il personaggio di Nala nel Nalacaritam).
In un’intervista, un insegnante del Kerala Kalamandalam disse: “… A disciple gets one fourth [of what he learns] from his teacher; the second quarter from himself; the third part from his classmates; and the last quarter in the long run of one’s life”.[18]
Lo scambio tra attore e personaggio è dunque implicito, ma non è prevista un’immedesimazione totale, prima di tutto poiché l’ambientazione Kathakaḷi è completamente extraquotidiana, non naturalistica, e poi perché l’attore è consapevole di essere su un palcoscenico, anzi deve maneggiare tutte le tecniche, le convenzioni, e le sue proprie emozioni, talmente bene da potersi dedicare all’espressione dei sentimenti del personaggio a cui sta prestando il corpo, essendo sempre consapevole del mood generale che quel testo racconta e allo stesso tempo delle rapide variazioni che il personaggio sperimenta nelle diverse situazioni in cui si trova.
Per spiegare il sāttvika spesso i Maestri di Kathakaḷi parlano di un vento interiore che, partendo dall’ombellico, si espande in tutto il resto del corpo, un’energia vitale, intangibile, che lega il respiro al movimento, al gesto, allo sguardo, alla mente.
Where the hand [is], there [is] the eye;
where the eye [is], there [is] the mind;
where the mind [is], there [is] the bhava;
where the bhava [is], there [is] the rasa.[19]
Lo spettacolo
Esiste un tipo di edificio teatrale, il Kūttampalam, appositamente disegnato secondo il canoni del Nāṭya Śāstra, per ospitare gli spettacoli di Kathakaḷi, che possono però anche aver luogo in semplici edifici rettangolari, debitamente attrezzati per gli spettacoli. Nel Kathakaḷi non ci sono scenografie, tutto è evocato con la recitazione o con semplice elementi (ad esempio i ciuffi di verde per mostrare una foresta), c’è però un tipo di sipario, il tiraśsīla, un panno di seta colorata tenuto in mano da due aiutanti di scena. Il tiraśsīla serve per chiudere o aprire delle scene, ma viene spesso utilizzato quando un personaggio importante deve fare la sua entrata in scena: questi si nasconde dietro il sipario che afferra con entrambi le mani strattonandolo o accarezzandolo a seconda del personaggio.
Tra i rari oggetti di scena (una mazza, una spada, ecc), lo sgabello assume un ruolo importante poiché è presente in molte scene del Kathakaḷi e serve sia come sedia vera e propria, ma anche come piedistallo per un personaggio divino.
L’aspetto sacrale del Kathakaḷi è ricordato a ogni spettacolo, poiché in proscenio al centro del palco viene posta una tipica lampada indiana ad olio in ottone, che deve restare accesa per tutta la durata dello spettacolo e che una volta era anche la sola fonte di luce; ora ci sono luci (spesso al neon) e ventilatori a rovinare l’atmosfera caratteristica, intima e sospesa, tipica del teatro antico indiano.
Tradizionalmente gli spettacoli di Kathakaḷi iniziano verso le otto di sera con l’annuncio dei musicisti che suonano per tutto il villaggio. Quando gli spettatori si sono radunati, cominciano i preliminari rituali, quali l’accensione della lampada e l’introduzione propiziatoria musicale del maddaḷam e dei cembali. Poi dietro al tiraśsīla, viene eseguita una danza preliminare tōṭayam, a cui segue il canto dei versi si apertura dell’opera in scena, e di nuovo un’altra danza di apertura la purapāṭu, questa volta eseguita davanti al tiraśsīla con due costumi (personaggi) identici ai protagonisti della storia di quella sera. Questa prima parte preliminare, che dura circa un paio d’ore, termina con la mēḷappadam un’improvvisazione con tutta l’orchestra, nella quale tutti i musicisti hanno la possibilità di mostrare le loro abilità artistiche.
Solo intorno alle ore 22.00 inizia la storia vera e propria che dura tradizionalmente fino all’alba, mentre spesso oggi vengono presentate performance più brevi, con solo due o tre scene di un’opera e saltando parte delle sezioni preliminari, e al termine viene eseguita una danza conclusiva benedicente chiamata dhanāśi.
Le platee sono normalmente disomogenee poiché uniscono spettatori esperti di Kathakaḷi a gente comune, a bambini che amano i costumi o stranieri che credono di assistere allo spettacolo folcloristico. Ma tutti alla fine della performance, faranno un applauso brevissimo (qualcuno si alza senza nemmeno applaudire), poiché in India l’apprezzamento o la critica, si esprime andando direttamente dall’attore o dalla troupe, oppure tenendosi l’esperienza per sé.
Spesso durante gli spettacoli che durano tutta la notte, gli spettatori mangiano, parlano, si alzano e si addormentano ma come disse Kalamandalam K.M. John in una seminario per attori occidentali, “… non dovete aspettare di prendere energia dal pubblico, perché loro non sono lì a darvi energia, ma dovete offrirla voi […] chi danza crea energia”.[20]

È una danza offerta alla divinità, a Śiva, perché protegga gli attori e conduca a buon fine lo spettacolo. I due danzatori interpretano Māyā, l’Illusione, e Śaktī, l’Energia creatrice originaria. A me, come ospite del maestro di tamburo, è permesso assistervi, da un lato della scena. I due attori iniziano la danza lentamente […]. Gli occhi si muovono più volte velocemente da destra a sinistra […] D’improvviso le ginocchia si piegano ad angolo retto verso l’esterno, le braccia aperte, tese, si pongono in linea con le spalle, le mani pendono rilassate. Tutto il corpo è posto su di un unico piano immaginario. La schiena è tesa ad arco. Con un salto ritmico i due danzatori portano il piede sinistro in avanti, in alto, all’altezza del viso, un braccio in avanti, l’altro verso l’alto. Iniziano a descrivere coreografie di immaginari esatti quadrati, danzando con corpi scattanti e flessuosi, facendo continui salti acrobatici. Gli occhi, in perpetuo movimento, sembrano emettere bagliori, la fronte e le guance vibrano in un tremito interrotto. È un’immagine sorprendente di come un uomo possa padroneggiare totalmente il proprio corpo […]. Uno spreco di energie che ha dell’incredibile, la sensazione di un accumulo estremo di vitalità che si sprigiona dalla spina dorsale e pervade tutti i muscoli dell’attore – alcuni affatto rilassati, altri tesi al parossismo – dandogli una misura quasi non più umana. E tutto questo rimane invisibile agli spettatori.
(Marotti, Ferruccio, Il volto dell’invisibile – studi e ricerche sui teatri orientali, Bulzoni editore, Roma, 1984, pagg. 141-169)
[1] Savarese, Nicola, Il teatro eurasiano, Laterza, Roma-Bari, 2002
[2] Barba, Eugenio, Teatro. Solitudine, mestiere, rivolta, Ubulibri, Milano, 1996.
[3] Cfr. Brecht, Scritti teatrali, Einaudi, Torino, 1975
[4] Grotowski, Jerzy, Oriente/Occidente, in Teatro Oriente/Occidente, a cura di A.Ottai, Bulzoni, Roma 1986. Estratto da Savarese Il teatro eurasiano. Op cit.
[5] Per approfondire il lavoro di Barba, segnaliamo al testo Teatro. Solitudine, mestiere, rivolta, il dizionario di antropologia teatrale di Barba e Savarese L’arte segreta dell’attore, Ubulibri, 1996.
[6] Savarese, Nicola, Teatro e spettacolo fra Oriente e Occidente Laterza, Roma-Bari, 1992, pag. 173
[7] Secondo la teoria estetica indiana rasa significa sapore, gusto, succo, ma “esperienza estetica” è la definizione, coniata da Raniero Gnoli, comunemente adottata.
[8] L’antica popolazione pre-aryana autoctona dell’India del Sud.
[9] Zarrilli, Philip B. The kathakali complex, Abhinav Publications, New Delhi, 1984. pag. 43. Il Malayālam (pron. malialam) è la lingua ufficiale del Kerala.
[10] Varadpande, M.L. History of Indian Theatre. Loka Ranga. Panorama of Indian Folk Theatre, Abhinav Publications, New Delhi, 1992, pag. 60
[11] Esiste in proposito un dibattito aperto ben approfondito nel documentario francese scritto e realizzato da F. Soltan e D.Rabotteau, Inde des dieux e des hommes, France tèlèvision distribution, 2003.
[12] Zarrilli, P.B. op. cit. pag. 47
[13] Brook, Peter, Il punto in movimento 1946-1987, Ubulibri, Milano 1987, pag.150.
[14] Già dagli esordi il Kathakaḷiha sempre presentato degli stili diversi in base alla regione di sviluppo. La divisione nord sud è rimasta fino ai giorni nostri, e per uno spettatore poco esperto è difficile notare la differenza, mentre per un conoscitore c’è un grande divario: a grandi linee possiamo dire che lo stile del nord (come quello Kalamadalam) è apprezzato soprattutto per la perfezione della tecnica, mentre quello del sud (scuola Margi) è conosciuto per la libertà espressiva che lo stile permette.
[15] Cap. VIII, da pag 114 op. cit.
[16]Sāttvika letteralmente significa purezza, conoscenza profonda. Secondo il teatro classico indiano, i primi tre tipi di abhinaya si occupano dell’espressività esteriore, il sāttvika di quella più interiore, meno visibile ma molto più significativa.
[17] Alcuni personaggi possono emettere versi, suoni selvaggi, ovviamente studiati e codificati, che possono indicare ad esempio l’animalità o la ferocia di un personaggio.
[18] Intervista a Kalamandalam Bala Subramaniyan, 1993 in Zarrilli Phillip B. , Kathakali dance-drama, where gods and demons come to play, Routledge, London, 2000.
[19] Da uno çloka dell’Abhinayadarpa±a, un antico trattato (X-XIII sec) di Nandikeśvara, tradotto da Zarrilli, op. cit.
[20] Kalamandalam K.M. John, stage presso la Scuola di Teatro “Teatri Possibili” di Milano il 26/27 novembre 2005.
Questo testo sul teatro Kathakaḷi è tratto dalla tesi di Laurea in Indologia di Lucrezia Maniscotti, conseguita presso la Facoltà di Lettere Moderne dell’Università degli Studi di Milano sotto la guida del Prof. Giuliano Boccali. Lucrezia Maniscotti è attrice, insegnante, danzatrice e studiosa di Teatro Danza indiano.
Per informazioni: m_lucrezia[AT]hotmail.com