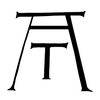Per gentile concessione del TTB, pubblichiamo questo estratto dal libro di Renzo Vescovi, “Scritti dal Teatro Tascabile” a cura di Mirella Schino, Bulzoni Editore 2007.
Perché l’India
Introduzione di Mirella Schino
Intorno al 1997, il Tascabile cominciò a pensare ad un libro sulla propria vicenda indiana, iniziata circa vent’anni prima. Il primo passo furono racconti, scritti in prima persona, e indirizzati al curatore, che ero io. Perchè l’India è il racconto di Renzo Vescovi.
Molte altre volte, tra l’anno del primo viaggio in India e l’anno della sua morte, Vescovi è tornato a scrivere o a parlare dell’India, delle peculiartà della cultura e del teatro indiano, delle tecniche e la storia dei diversi generi di teatro-danza indiano, della figura di Gandhi, o delle differenze tra attori occidentali e attori orientali. Ma la lettura di questa breve narrazione della fine degli anni Novanta, dal sapore un po’ più autobiografico del solito, ci è sembrata dovesse essere preliminare: una introduzione ad altri saggi, più meditati o più eruditi.
Alcune informazioni sono essenziali alla lettura del testo: “Min fars hus”, “La casa del padre”, cui Renzo Vescovi fa riferimento è lo spettacolo di Eugenio Barba del 1972 con cui l’Odin Teatret fu di fatto conosciuto dal pubblico italiano (anche se il gruppo danese era stato già presente in Italia con lo spettacolo precedente, “Ferai”), suscitando un’onda di interesse all’interno di una larga fascia di teatranti, che produsse, negli anni immediatamente successivi, incontri, e collaborazioni: gli appuntamenti annuali del festival di Santarcangelo, “L’Atelier del teatro di gruppo”, che si è svolto a Bergamo nel 1977, e insomma tutto quel vasto movimento che fu definito dai giornalisti, a partire da una definizione dello stesso Barba, “il Terzo Teatro italiano”.
Torgeir Wethal è un attore dell’Odin Teatret, uno degli attori fondatori. Krishnan Nambudiri, intellettuale e conoscitore di danza Kathakali indiano, fu invitato da Eugenio Barba all’Atelier di Bergamo del ’77, dove si esibì in danze e dimostrazioni. Ferdinando Taviani, studioso di storia del teatro, è anche consigliere letterario dell’Odin Teatret, e vecchio amico di Vescovi e del Teatro Tascabile. Ferruccio Marotti, studioso di storia del teatro, ha contribuito, con i suoi studi, e talvolta anche con il suo lavoro organizzativo, alla riscoperta del teatro orientale, in particolare indiano e balinese. Aloka Panikar, danzatrice indiana, una delle più grandi interpreti dello stile Orissi, è stata, ed è tuttora, maestra di danza e cara amica per il Tascabile. Rukmini Devi, 1904-1986, è stata una personalità straordinaria, e non solo dal punto di vista delle arti. Si è attivamente adoperata per tutta la vita per recuperare e conservare diverse tradizioni artistiche indiane in declino, in particolare lo stile Bharata Natyam, nella accademia culturale da lei fondata, il Kalakshetra.
Il mio compito dovrebbe essere rispondere alla domanda che sempre, con curiosità, con malignità, con sottile ironia, con perplessità, ci viene fatta. Una domanda che talvolta è diretta, più spesso è sottintesa, o tacita. La domanda è: ma perché l’India? Non è, del resto, una domanda a cui sia facile rispondere. Forse in periodi diversi avrei dato risposte diverse. O forse dovrei dare una risposta che comprende, in realtà, più risposte insieme, complementari e perfino contraddittorie. Forse è più facile fare la storia della nostra ricerca di una via delle Indie che rispondere.
Ho incontrato Eugenio Barba e le persone dell’Odin Teatret (ma almeno uno spettacolo già lo conoscevo) nel 1973[1]. E in un certo senso tutto cominciò da lì. Un punto di partenza per l’India che può sembrare strano solo a posteriori.
Un’amica molto cara, morta da qualche tempo, che ancora riverisco per la sua grandezza d’animo (si chiamava Lidia Gavinelli, a quei tempi era così bella che al suo passaggio nei corridoi della Statale la gente, ricordo, si fermava ammutolita), aveva visto a Venezia lo spettacolo dell’Odin di quegli anni, Min Fars Hus. Lidia era una donna davvero notevole, non solo bellissima e ricca, ma anche molto colta. Sensibile. Di estrema sinistra. È stata direttrice e regista del Teatro Tascabile e per anni, dal ’64 al ’72 circa, lo ha finanziato con molta discrezione (allora non era un teatro professionista). Tra l’altro aveva investito parecchio denaro per trasformare una topaia che ci era stata concessa dal Comune in piazza Cittadella in un vero e proprio teatrino, con palco, gradinata e anche un sipario. Io collaboravo come attore e come regista. Nel ’72 ci fu un’immissione di nuove leve di attori, io divenni l’unico regista, e Lidia, che si stava dedicando sempre più a tempo pieno alla politica, mano a mano si staccò. Le dobbiamo molto.
Nel ’73, Lidia aveva dunque visto l’Odin a Venezia, le sembrò tanto significativo che mi mandò a vederlo pagandomi il soggiorno di una settimana presso la Biennale. Lei, ai tempi, pensava di ampliare l’attività della Compagnia di allora con una politica di ospitalità mecenatesca. Invitammo dunque Giovanni Poli dell’Avogaria, e poi Min fars hus. Lo spettacolo costava parecchio, e per poterne avere almeno due o tre repliche Lidia vendette un appartamento. Io, all’epoca, oltre a fare il regista, ero assistente di Letteratura italiana alla Statale e insegnavo in un istituto professionale di Milano. Avevo visto lo spettacolo precedente di Eugenio Barba, Ferai, ma se devo dire la verità quello che mi aveva colpito di più era stato Barba stesso, con cui avevo avuto un breve colloquio a fine spettacolo.
Nei giorni di Min Fars Hus eravamo tutti seduti riverenti ai piedi degli attori dell’Odin: dialoghi, vere e proprie interviste etc. Ricordo che io insistevo con talmente tante domande sulla tecnica che alla fine Torgeir Wethal ne fu leggermente infastidito.
Quella della tecnica era una questione assolutamente fondamentale, per me.
Fin dall’inizio, il mio e il nostro grande problema era stato quello: l’autodidattismo. Il desiderio di lanciarmi in quelle che mi figuravo come grandi impennate poetiche era sempre frenato dal timore di mortificanti gaffe sintattiche. Penso derivi anche da questo un certo corso del nostro lavoro che definirei di “conquista delle tecniche”: dall’acrobatica all’arte del giocoliere ai trampoli all’uso della voce e della musica fino ad arrivare, appunto, alla danza indiana e balinese. E tuttavia quest’ultima tappa è così intrecciata a mutamenti più generali del profondo che sarebbe ingiusto metterla solo come stazione provvisoriamente finale di un cammino lineare progressivo. Ma il discorso sull’India concerne profondamente, per me, la questione della tecnica, e dunque il contesto, che a prima vista può sembrare lontano, della cultura artigianale del teatro di gruppo, e soprattutto dell’Odin Teatret, in quanto incarnazione stessa della (o di una) tecnica artistica ignota o estranea al “normale” teatro occidentale.
Per un lungo periodo il mio sogno era stato quello dell’attore giullare, un attore che, in opposizione a tutte le statiche caratteristiche della tradizione italiana – ma forse occidentale tout court – contemporanea, sapesse suonare e fare i salti mortali: mi pareva che in questo modo dolcezze e vitalità, dolori e canti potessero essere espressi con maggiore fantasia ed efficacia.
Così la tecnica era concepita come mezzo per piegare il corpo a qualsiasi intento espressivo e il riferimento era quello, romantico e mitico, di Paganini e del suo violino. L’escalation progressiva della tecnica (così ingenuamente intesa), coniugata alla casualità dello svolgersi degli avvenimenti, ci portò con naturalezza fino alla soglia del teatro orientale. Sapevamo ormai fare ogni acrobazia: salto mortale e flip-flap (la vetta, ai tempi inaccessibile, della tecnica teatrale del corpo) erano conquistati. Potevamo mai, i barbari giullari, gli straccioni mangiafuoco sui trampoli, dedicarci alle più raffinate e sofisticate acrobazie degli occhi, delle dita e dei muscoli pellicciai?
Fu perciò che, quando Krishnan Nambudiri arrivò, invitato da Eugenio Barba, all’Atelier di Bergamo (settembre 1977), e cominciò la lunga sequenza dei seminari italiani, fummo tra coloro che lo ospitarono più a lungo: mi sembrava vagamente sacrilego non profittare della disponibilità di un grande artista del mitico Kathakali[2]. E tuttavia sentivo il disagio di disperdere il nostro lavoro di ricerca in uno spreco al limite del gratuito: che fare di questa pioggia di manna dal gusto sconcertante in un periodo in cui ero tutto proiettato verso altri alimenti di sapore più famigliare? Domanda fondamentale fra quelle che incominciavano appunto ad accumularsi, elidersi, sovrapporsi e intrecciarsi ai mozziconi di risposta e alle considerazione che mi sarei poi continuamente trovato sul cammino.
All’inizio mi interessò soprattutto la figura del Maestro; poi mi emozionò molto la consapevolezza di essere di fronte all’assoluto teatrale; poi esaminai come potevo i contenuti tecnici di quelle lezioni per ricavarne insegnamenti e conferme.
L’atteggiamento complessivo restava comunque una reverenza totale a un universo inconoscibile, con una disposizione insieme timida e ansiosa ad assorbire quanto più si poteva in termini di aspirazione assoluta e per così dire metafisica e oscura, e ad acquisire la maggiore quantità possibile di minuteria tecnica col surrettizio proposito di riciclaggio, manifesto e dissimulato, nella cornice più famigliare della ricerca in corso.
In questo contesto ci arrivò notizia di Aloka.
Fu Ferdinando Taviani che per primo ci parlò della danza Orissi che aveva visto a Holstebro. Quando gli chiesi che cos’era mi rispose con un sospiro che quella era la bellezza pura. Fu una tentazione: su quel sospiro impegnai il mio teatro a un rischioso sforzo economico per avere qualche settimana una danzatrice Orissi che Ferruccio Marotti stava per invitare in Italia: Aloka Panikar. Era il 1978, e aveva ragione Taviani: quella era la bellezza pura. Con Aloka facemmo un seminario, e quello stesso anno cominciarono le nostre partenze per l’India. Il mio intento era semplice: possedere quella bellezza! Come nei romanzi d’appendice: col punto esclamativo e a ogni costo.
Non ci fu molta lucidità, in quella smania.
Da un punto di vista più razionale, posso dirti che pensai che i miei colleghi registi dei gruppi erano troppo impegnati a usare la loro creatività, talvolta anche geniale, per perdere troppo tempo in tecniche tradizionali non facilmente utilizzabili, e “non nostre”. Io mi sono sempre sentito un artigiano, non un artista. Volevo imparare la lingua da principio, dall’alfabeto, e proprio dai maestri più preparati del globo. Arnold Haskell, storico della danza occidentale, ha definito la danza indiana “il più completo e il più espressivo di tutti i sistemi di danza”. Lo cito spesso: mi è sempre sembrato che questo autorevole giudizio e la realtà cui esso fa così perentorio riferimento siano ragioni sufficienti a giustificare qualsiasi attività volta a promuoverne la conoscenza.
Non credo che spiegai tutto questo ai miei compagni, ma quando la mia proposta di impegnarci in un lungo studio di tradizioni artistiche aliene apparve loro troppo strana, e si impelagò negli abituali problemi di soldi e organizzazione, diedi una grande palmata sul tavolo e mi impuntai.
Però c’era anche l’altra faccia, la smania di possesso: la passione. L’innamoramento è un’esperienza turbolenta e nessuno si meraviglia che la sua forza biologica e vitale si rovesci nel creato anche distruggendo, senza curarsi del bon ton, spesso straripando da argini in cui sarebbe forse bene che si contenesse. La pulsione per l’India fu razionale, fu bisogno di tecnica, e al tempo stesso fu cieca come un amore romantico. Tuttavia cercai di difenderla di fronte all’esterno e a me stesso.
Per molto tempo, dopo aver intrapreso lo studio delle danze classiche indiane e balinesi, continuammo dunque a dare risposte note e tranquillizzanti alle domande sul senso di ciò che s’andava facendo.
Avevo per esempio già pronto un piano per rifare a modo mio lo spettacolo guida di Eugenio Barba, Il Milione, di cui sapevo senza averlo visto (avevo resistito fino ad allora alla tentazione di vederlo) che era, fra l’altro, un’elaborazione personale di Kathakali e Baris balinese. Poi non attuai quel piano: come succede a certi esploratori, non seppi risolvermi a lasciare per tempo il territorio sconosciuto, mi ci inoltrai tanto che finii per smarrirmi.
Ora assisto alla danza dei miei compagni con occhi sempre diversi. Per molto tempo li ho visti come uno spettatore esterno: lavoravo con loro controllando su di me “l’intensità” generale della loro interpretazione. Ora non più: il mio interesse si è spostato e durante le prove adesso sono preoccupato di tutt’altro: l’angolo delle braccia, l’inclinazione del collo, la correttezza degli sguardi, la flessione delle ginocchia.
L’India è venuta così, per quella smania che Aloka mi mise addosso fin dal mio primo sguardo sulla sua danza. Ma anche, in buona misura, perché mi sembrava che la trisecolare storia artistica e il costume del teatro tradizionale europeo avessero esaurito la loro spinta feconda. Così la questione era non tanto di combattere quella cultura quanto di uscire da quella logica.
Ma a partire da dove? Dalle suggestioni dell’avanguardia italiana o europea? Il terreno su cui poggiava il piede per la battuta di scatto poteva essere cedevole, privo com’era di una sua stratificazione geologica convenientemente sedimentata. Il rischio era di basarsi su di un quadro di riferimento in realtà troppo equivalente a quello che si combatteva. Per mancanza di precise coordinate su cui orientarsi si potevano avere o cercare contrapposizioni o alternative che insomma rischiavano di essere come la zuppa al pan bagnato.
Giacché non si tratta qui di modificare le intonazioni del monologo e neppure di cambiarne le battute, ma di danzarlo: “E così [Sada Yacco][3] conquistò il pubblico. Non con le battute né con la musica né con altri accorgimenti ma solo quando fuse la sua recitazione con l’orchestra”. Così raccontava Mejerchol’d,[4] e sanciva l’esempio con il riconoscimento di un debito: “Tutto questo noi lo abbiamo imparato dal teatro antico”. A Nicola Savarese devo l’accostamento di questa citazione con un’altra di E.G. Craig che egli riporta, come la prima, su un numero di “Sipario” del 1980:
“Tutt’ora la Natura sembra scoprire che la vecchia strada sia la migliore via della creazione. Essa produce risultati precisamente attraverso gli stessi metodi che ha impiegato milioni di anni fa. Le sue montagne, i suoi fiori, le sue lune e i suoi uomini sono probabilmente in tutto differenti da quello che erano una volta ma nel produrli essa non ha fatto la corte ai nuovi mezzi”.
L’artista che segue questa legge della natura non fa male.
Così partì il nostro cavallino delle tecniche dirette: alla ricerca di un discorso tecnico-antropologico sull’arte dell’attore che per me era cruciale. E alla cattura della bellezza assoluta.
Ma forse, alla domanda perché l’India dovrei rispondere anche in un altro modo, che può sembrare banale, da vero europeo. Non con spiegazioni, ma con ricordi, immagini. Qualcosa che, sì, resta nel cuore e negli occhi.
L’odore dell’aria di Bombay.
Il Kalakshetra, la scuola di Rukmini Devi, e il grande banyan che vi sta al centro, con la piccola statua di Gaṇeśa collocata tra le radici.
I treni lenti dell’India, con le porte aperte sugli scalini dove ci si può sedere e guardare da soli, i gomiti sulle ginocchia, il paesaggio che scorre.
Il mare sempre tiepido di Kovalam.
Ricordi da turista, già, ma ribaditi, reiterati, assorbiti, incorporati come un cataplasma. Forse l’India per noi è come una casa natale, a cui si può sempre tornare, ma in cui non devi vivere.
Molti anni fa, l’11 luglio 1980, a Mantova, abbiamo presentato un’edizione straordinaria delle nostre Tavole d’Atlante dedicate alla danza Orissi. Il complesso orchestrale degli attori era diretto dal nostro Guru che per l’occasione suonava personalmente il pakhawaj (il tamburo tipico di questa tradizione). E prima dello spettacolo, il Guru aveva rifinito il trucco e fissata con grande abilità la classica corona delle Mahari[5] sui capelli delle mie compagne danzatrici: e naturalmente, prima di precederle in scena, le aveva benedette.
NOTE
1 Il Nordisk Teaterlaboratorium, più noto come Odin Teatret, è una compagnia teatrale multiculturale fondata da Eugenio Barba ad Oslo nel 1964 e in seguito stabilitasi in Danimarca.
2 Teatro-danza del Malayalam, il più meridionale degli Stati dell’India del Sud.
3 Attrice e danzatrice giapponese, 1871/1946.
4 Vsevolod Emil’evic Mejerchol’d, 1874-1940, è stato un regista russo.
5 Le Mahari sono danzatrici che un tempo erano dedicate nel tempio del dio Jagannatha a Puri.
Leggi anche: Il sapore della danza